Deposizione dell'Allamano al processo del Cafasso
- Dettagli
- Scritto da Giuseppe Allamano
L'ALLAMANO RACCONTA LA SANTITÀ DEL CAFASSO
DEPOSIZIONE AL PROCESSO CANONICO
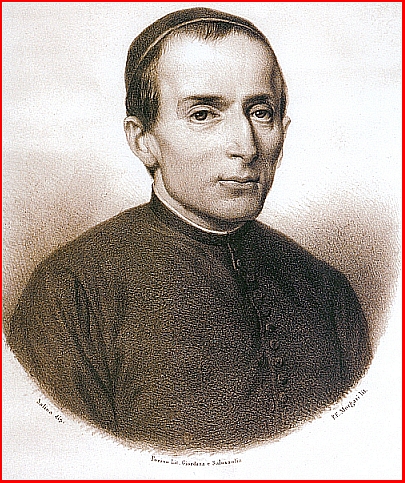
Il tribunale ecclesiastico per il processo canonico di Don Giuseppe Cafasso, morto nel 1860, fu costituito a Torino dall'arcivescovo mons. Davide Riccardi il 16 febbraio 1895, dietro richiesta dell'Allamano.
Di questa causa l'Allamano fu l'iniziatore e il promotore. Venne pure chiamato a deporre come testimone, prima nel processo ordinario diocesano, dal febbraio al novembre 1897, e poi nel processo apostolico, nella primavera del 1907. La sua deposizione, che si fonda su un numero incredibile di testimonianze raccolte personalmente, è senza dubbio la più ricca ed importante che si possa leggere nei volumi del processo. Egli segue il tracciato dei 336 articoli (una specie di questionario) che compendiano la vita del Cafasso. Egli ne delinea la figura pacatamente nel corso di 39 sessioni.
Riportiamo qui la deposizione processuale dell'Allamano sullo zio, come è stata pubblicata dalla nostra rivista “Il Servo di Dio Giuseppe Allamano “tesoriere della Consolata”, negli anni 1985-1986.
I - « MI CHIAMO ALLAMANO GIUSEPPE »
Io mi chiamo Allamano Giuseppe del fu Giuseppe e della fu Marianna Cafasso, nato in Castelnuovo d'Asti nel giorno 20 [ !] gennajo 1851, Canonico onorario della Metropolitana di Torino, Rettore del Convitto Ecclesiastico e del Santuario della Consolata in Torino: di condizione agiato.
Ogni anno ho sempre adempito il precetto pasquale. Celebro la messa tutti i giorni, e mi confesso ordinariamente ogni otto giorni.
Nessuno mi istruì o a voce o in iscritto in ciò che avrò da deporre in questa Causa del Servo di Dio Giuseppe Cafasso. Ho letto la Vita di detto Servo stampata in Torino dalla Tipografia Canonica, essendone autore il Can.co Giacomo Colombero, e la Biografia del medesimo scritta da Don Giovanni Bosco fondatore dei Salesiani, e stampata nelle Letture Cattoliche nel 1860 dalla Tipografia Paravia in Torino. Nelle mie deposizioni non mi servo delle notizie che si trovano nella vita suddetta, ma dico cose che ho udito ed avute per iscritto dai testi, con cui ebbi relazione, e che citerò volta per volta. Io vidi una volta sola il Servo di Dio a Castelnuovo d'Asti avendo allora io poco più di seí anni, cioè nel 1857.
«NON POSSO NEGARE DI AVERE UNA CERTA AFFEZIONE ED ANCHE VENERAZIONE»
Fin dalla prima età, essendo in patria, al sentir parlare così bene, in casa e dai compaesani, del Servo di Dio, come di un sacerdote modello e caritatevole, lo ammirava; la quale ammirazione aumentò e crebbe quando trovatomi nell'Oratorio Salesiano di Torino per gli studii ginnasiali, lo udiva proposto per modello dall'esimio Don Bosco. In seguito, fatto chierico, pel contatto maggiore coi Sacerdoti della Diocesi si accresceva sempre più la mia stima verso il Servo di Dio. Fatto poi sacerdote nel 1873 per l'accresciuta comunicazione coi sacerdoti, massime del Convitto, dove andava per udire le conferenze, viemmaggiormente appresi a stimare il Servo di Dio. Esortato nel 1876 da Monsignor Galletti Vescovo d'Alba a raccogliere le memorie per una vita del Servo di Dio, come pure dal Padre Pellico della Compagnia di Gesù, e dal Can.co Bosso che fu poi Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza, defunti tutti tre, dall'ultimo dei quali ebbi pure un indice per comporre tale vita, mi diedi attorno a comporla come feci e la condussi fino al suo ingresso in Convitto. Questa fu riveduta dal Teologo Bertagna, ora Vescovo titolare di Cafarnao, vivente, che pure mi animava vivamente a quest'opera. Se non che per ragione delle mie molte occupazioni come Direttore Spirituale del Seminario Metropolitano di Torino, e poi Rettore della Consolata, dovetti sospendere quel lavoro. Un motivo anche di questa sospensione fu di non sentire in me quell'entusiasmo che osservava in altri e quindi il vedermi incapace di ben esprimere la stima e la venerazione che osservava in quanti l'avevano conosciuto, verso il Servo di Dio.
Qualche tempo prima di sua morte Don Bosco, da me interrogato perché non avesse adempito alla promessa, che aveva stampata sulla copertina d'un elogio funebre, egli rincrescente di non averlo potuto fare per le sue molte occupazioni, non senza qualche speranza di ancora farlo, mi esortava a comporre una circolare con vari quesiti e di spedirla ai molti conoscenti di don Cafasso che sopravvivevano, accertandomi che avrei potuto raccogliere tante notizie da comporre una bella vita.
Nel 1892, mi pare, spedii detta Circolare e ne ebbi molte risposte che consegnai al Can.co Colombero, il quale su quei documenti e sulle mie memorie compose la vita suddetta. Da quanto ho detto non posso negare di avere una certa affezione ed anche venerazione pel Servo di Dio. Desidero pure la sua Beatificazione pel gran bene che ne verrebbe al Clero principalmente, ed anche ai fedeli tutti, essendo stato esso, a mio parere, modello di ogni virtù sacerdotale e cristiana. Nessun motivo umano mi induce alle mie deposizioni, ma unicamente la gloria di Dio e il bene delle anime.
LA FAMIGLIA DI DON CAFASSO
 Dall'atto di nascita e battesimo che ho rilevato dai registri della Parrocchia di mio paese, e che presento ora in questo Processo, risulta che il Servo di Dio nacque in Castelnuovo d'Asti il giorno quindici gennajo dell'anno mille ottocento undici e fu battezzato nella parrocchia di S. Andrea Apostolo nel giorno seguente. I suoi genitori furono Cafasso Giovanni ed Orsola Beltramo coniugi. Egli ebbe un fratello per nome Pietro e tre sorelle per nome Maddalena, Francesca e Marianna.
Dall'atto di nascita e battesimo che ho rilevato dai registri della Parrocchia di mio paese, e che presento ora in questo Processo, risulta che il Servo di Dio nacque in Castelnuovo d'Asti il giorno quindici gennajo dell'anno mille ottocento undici e fu battezzato nella parrocchia di S. Andrea Apostolo nel giorno seguente. I suoi genitori furono Cafasso Giovanni ed Orsola Beltramo coniugi. Egli ebbe un fratello per nome Pietro e tre sorelle per nome Maddalena, Francesca e Marianna.
Al Servo di Dio furono imposti i nomi di Giovanni Giuseppe. Io so il numero di tale famiglia perché eccettuata la sorella Maddalena li conobbi personalmente, essendo sopravvissuti al Servo di Dio. Io non conobbi i genitori del Servo di Dio, ma dalla mia famiglia e parenti e dalla gente del paese appresi, che essi erano contadini di modesto patrimonio, persone oneste, pie e caritatevoli. È prova della pietà del Padre, l'aver egli appartenuto all'antica Compagnia della Beata Vergine di Montariolo presso Sciolze dal 1818 fino alla morte nel 1848. Detta Compagnia era composta di 250 confratelli, parte ecclesiastici parte laici, di provata pietà. So questo dal Teologo Audisio attuale pievano di Sciolze, che ne esaminò i registri, e trovò che adempié sempre regolarmente l'obbligo suo, ed io lessi pure nel suo testamento che non lasciava altre messe da farsi celebrare avendone cinquecento da detta Compagnia. Da uno degli attuali Vicecurati di Castelnuovo d'Asti, che credo sia Don Bertagna, seppi che egli lesse i registri della Compagnia del Suffragio, e che vi trovò regolare l'iscrizione e l'adempimento degli obblighi annessi per conto del Padre di Don Cafasso: pel che in morte gli furono celebrate altre 100 messe, come portano gli Statuti della Compagnia. Dalla voce comune nel paese raccolsi che il detto padre di Don Cafasso era uomo semplice e retto ed assiduo alle funzioni di Chiesa.
Foto: Sorella del Cafasso e mamma dell'Allamano
Quanto alla madre del Servo di Dio il Sig. Chiardi Felice, coetaneo di Don Cafasso, e suo compatriota, defunto pochi anni fa, mi disse queste testuali parole: che la madre era donna virile, piena di carità verso i poveri, cercata e desiderata da tutti in ogni sorta di bisogni. Turco Giuseppe, pure di Castelnuovo, e coetaneo del Servo di Dio, defunto, Ostino Francesca e Cafasso Rosa, nipoti entrambi di Don Cafasso, viventi, mi attestano che la madre di Don Cafasso era molto portata per gli infermi, pei quali preparava certi rimedii e teneva sempre pronte candele, lenzuola e cuscini che portava essa stessa ai poveri, ne puliva e metteva in ordine la stanza per prepararli a ricevere il Santo Viatico. - Ciò mi dissero per aver visto. - Detto Turco Giuseppe aggiunsemi che tale era la stima che godeva presso il paese la detta madre del Servo di Dio, pell'ajutare spiritualmente i moribondi che un certo Filippa, un signore del paese, uomo poco di Chiesa, la fece chiamare per essere da lei assistito nel punto di morte; e mi disse pure che in tali circostanze la madre del Servo di Dio accorreva anche non chiamata.
Custodiva sì gelosamente la figliolanza che nella prima e sola volta che permise alla sua figlia Francesca di parlare col futuro sposo, stette continuamente seduta tra essi due. Questo mi attestò la figlia di detta Francesca, Matta Maria vivente, che lo seppe dalla sua madre. La voce comune nel paese, che dura ancora nei pochi vecchi che l'hanno conosciuta è che fu un modello di vera madre cristiana.
PRIMA FANCIULLEZZA
Dall'atto di cresima, che pure presento qui ai Rev.mi Sigg. Giudici, consta che Don Cafasso ricevette la santa Cresima nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Moncucco Torinese da Monsignor Alessandro d'Angennes allora Vescovo di Alessandria il sedici settembre dell'anno mille ottocento ventitre. Ignoro le particolarità, con cui il Servo di Dio abbia ricevuto detto Sacramento.
Il fu Don Allamano Giovanni mio Zio paterno che fu Prevosto di Passerano per 36 anni, di qualche anno maggiore del Servo di Dio, nativo di Castelnuovo d'Asti, che fu compagno al Servo di Dio in tutte le scuole fino a quella del Convitto inclusivamente, essendo sempre nello stesso corso, mi disse che vide il Servo di Dio essere di gracile complessione e di debole salute e sui tredici anni circa piegò un po' della persona verso sinistra, onde si temeva della sua vita; tuttavia non fu mai propriamente ammalato. Mi soggiunse che vide il Servo di Dio fin dalla più tenera età dimostrare indole molto vivace, che però sapeva ben dominare; vide che era dedito alla pietà e divozione; questo soggiungevami, è un fatto e non un'esagerazione come talora si dice dei fanciulli.
Aggiungevami ancora, che lo vedeva sempre al mattino andare per tempo a servir messa al Prevosto e Vicario Foraneo Sismonda, uomo di grande discernimento, del quale il Servo di Dio era il prediletto, per cui lo regalava di libri di devozione; vide che fin da fanciullo condusse vita ritiratissima andando solamente in Chiesa, in casa parrocchiale e da don Musso suo padrino; lo vide frequentare nessuno né alcuna casa, salutare i signori del paese, ma non mai trattenersi con alcuno.
Turco Giuseppe, sopramenzionato, mi disse che vide il Servo di Dio fin da fanciullo essere sempre cheto e raccolto, frequentare la Chiesa, servire la Santa Messa, assistere ai catechismi. Aggiunsemi, che essendo suo vicino di casa, sí trovava sovente con lui, che lo vide di edificazione ai suoi compagni, assiduo alla scuola e sì diligente da superare nello studio i compagni di età ed anche quelli di età maggiore.
Cafasso Pietro, fratello del Servo di Dio, mia madre Marianna, sorella del medesimo, entrambi defunti, Turco Rosa, vivente, ed altri ancora che non ricordo, mi narrarono aver visto il fanciullo Cafasso che collocatosi su una sedia o sul greppione della stalla predicava ripetendo con molta precisione le prediche udite in Chiesa e facevane anche delle sue; durando talvolta un'ora con piacere ed ammirazione degli invitati, che empivano la stalla, i quali per la brama di udirlo chiedevano quando avrebbero potuto ritornare. La memoria di tale fatto è tutt'ora viva nel paese e ne udii parlare da tanti.
Turco Rosa, già menzionata, mi raccontò che essendo vicina di casa vide il Servo di Dio invitare alla sera la famiglia, anche i servi a recitare il Santo Rosario, e nessuno si esimeva anche nel tempo della mietitura del grano, pel modo cortese ed affabile con cui li sollecitava. La medesima mi raccontò che seppe, non so come, che il Servo di Dio, avendo in casa un vaccaro balbuziente, a cui nessuno aveva potuto ancora far imparare le preghiere del Cristiano, privandosi anche in parte del riposo gliele insegnava parola per parola finché riuscì a fargliele imparare. Dalla medesima seppi che il Servo di Dio, vedendo sua madre comporre rimedi assai costosi per ammalati, la pregava così: mamma, fatemi il piacere, ai poveri dateli per amor di Dio. E così faceva la madre con gran consolazione del figliuolo.
La damigella Garneri, defunta, mi disse di aver udito, durante la sepoltura del Servo di Dio, da un Signore che essa non conobbe ma giudicò essere di Castelnuovo, che il Servo di Dio fino dall'età di sei anni era già un santetto e che già fin d'allora quando vedeva alcuno fra i suoi compagni venire fra loro a contesa, cercava di conciliarli, invitando l'uno a domandar perdono all'altro, soggiungendo: se non vi perdonate, nel dire il Pater Noster voi dimandate a Dio che vi castighi, e che quel Signore soggiunse che da fanciullo fino alla morte il Servo di Dio si conservò sempre uguale a se stesso. Non mi consta che il Servo di Dio sia stato a balia.
II - FREQUENTA LE SCUOLE A CASTELNUOVO
Turco Giuseppe, soprannominato, mi disse che si pensò dai parenti, subito che fu capace, di farlo studiare. E Don Allamano, già nominato, mi attestò che il Servo di Dio non lasciò mai di studiare per attendere ad altre cose, ma fatti i primi studii di italiano, fece scuola privata di sesta, quinta e quarta da Don Moglia, venerando sacerdote del paese, defunto. I due suddetti mi dissero questo perché compagni di scuola del Servo di Dio negli anni dell'adolescenza. Le dette scuole le fece in patria. Non sono informato con quale obbedienza e soggezione abbia il Servo di Dio frequentato le scuole. Nei documenti che presenterò durante questo Processo mi pare vi sia qualche cosa in proposito; al che mi riferisco.

A CHIERI PER LA SCUOLA DI LATINITÀ
Ho già detto sopra che il Servo di Dio fece le scuole elementari in patria sotto Don Moglia.
Circa ai 13 anni, come mi disse il citato Don Allamano, perché ognora compagno del Servo di Dio nelle varie scuole fino al Convitto, si portò a Chieri e per due anni attese alla terza latinità sotto il Padre Giusiana, Domenicano, celebre Professore, defunto; l'umanità e rettorica sotto il Padre Raviola, pure defunto. Il Sig. Chiardi Felice, defunto, mi disse: ci trovavamo assieme al Servo di Dio a Chieri in pensione presso un sarto di nome Cumino, defunto, che colla moglie abitava presso la Chiesa di S. Bernardino, ottimi cristiani; e mi aggiunse il medesimo, che il Servo di Dio lo spronava allo studio.
Don Allamano, già nominato, mi disse che il Servo di Dio facendo grammatica, ossia terza latinità, in Chieri, si portava ogni mattina per tempo alle funzioni dei Padri Domenicani nella Chiesa di San Domenico e nelle feste frequentava i catechismi dei Padri Gesuiti nella Chiesa di S. Antonio. Il medesimo mi raccontò che quando il Servo di Dio si presentò per la prima volta a questi catechismi, venne interrogato da quei Padri se fosse già promosso alla comunione per sempre, al che avendo il Servo di Dio risposto di no, detti Padri lo rimproverarono come di cosa che provenisse da sua colpa, ed egli piegò il capo e tacque. Ma ben presto quei Padri si disingannarono, ammirati del suo sapere e del suo contegno. Quanto alle funzioni di S. Domenico e ai catechismi, Don Allamano seppe ciò perché compagno continuo del Servo di Dio; quanto al fatto susseguente, Don Allamano mi disse che egli vi fu presente.
Io non sono informato come teste di audito da alcuno qual profitto il Servo di Dio abbia fatto nelle scuole accennate in questo Interrogatorio e quale sia stata la sua condotta sia verso i suoi maestri, sia verso i suoi compagni.
A questo punto, il teste Giuseppe Alla, mano produce due documenti, e cioè:
- l'atto di nascita e battesimo nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea in Castelnuovo d'Asti, il 16 gennaio 1811;
- l'atto di cresima nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Moncucco, il 16 dicembre 1823.
NON È ACCETTATO NEL SEMINARIO DI TORINO
Il citato più volte Don Allamano e per la causa di scienza ivi riferita, mi disse che il Servo di Dio, compiuta la rettorica, fece domanda di entrare quale chierico nel Seminario di Torino per studiarvi la filosofia, e non essendo stata accettata la sua domanda, per mancanza di posto e perché davasi la preferenza agli studenti venuti dal Seminario di Giaveno, per consiglio del Prevosto di Castelnuovo, Don Sismonda, si recò di nuovo a Chieri come secolare e studiò il primo anno di filosofia nel Collegio Civico sotto il Padre Sibilla, Domenicano. Lo stesso Don Allamano si trovò nelle medesime condizioni. Nel primo Luglio 1827, cioè terminato il primo anno di filosofia, il Servo di Dio vestì l'abito chiericale, come appare dall'atto rilasciato dalla Curia Arcivescovile dietro mia domanda e che porta la data 1° febbraio 1897 coll'inizio: Ex libris in hac Curia Archiepiscopali e che qui riproduco. (Il documento, riconosciuto e autenticato, viene allegato agli atti del processo).
A CASTELNUOVO E NEL SEMINARIO DI CHIERI
Lo stesso Don Allamano mi disse che entrambi si recarono poi a Chieri pel secondo corso di filosofia sotto lo stesso Padre Sibilla; che finito questo corso, per consiglio del Prevosto novello di Castelnuovo, Don Dassano, defunto, si fermarono in patria ed attesero ivi allo studio della teologia sotto la direzione dello stesso Prevosto; che terminati questi due anni scolastici sulla fine di ottobre dell'anno 1830 furono ammessi nel Seminario di Chieri, dove passarono tre anni scolastici, compiendo l'intero corso teologico sotto il Teologo Arduino, defunto, ed altri di cui non ricordo il nome. Inoltre io stesso vidi e consultai i registri delle confessioni del Seminario di Chieri, conservati nel Seminario Metropolitano di Torino; e vi riscontrai che realmente Don Allamano ed il Servo di Dio passarono i sopra indicati tre anni di teologia in Chieri.
Ho detto sopra che il Servo di Dio fece domanda di vestir l'abito ecclesiastico compiuta la rettorica; non seppi da alcuno quali segni di vocazione abbia dato in quell'epoca, né che abbia chiesto consiglio; sentii però a dire da parenti e conoscenti in patria, Don Allamano, mia madre, Turco Giuseppe, suddetti, ed altri, che l'aver il Servo di Dio vestito l'abito fu riguardato come la cosa più naturale in seguito alla sua buona condotta antecedente.
Riguardo alla filosofia mi disse Don Monsello, vivente, che un certo Don Chiais, compagno del Servo di Dio in filosofia, disse a lui, che Don Cafasso era dei più distinti in filosofia.
Quanto alla sacra teologia mi disse il citato Don Allamano che in tali studi il Servo di Dio si dimostrò amantissimo dello studio, che aveva molta memoria, ed ingegno più del comune, somma diligenza nello studiare e che fu sempre dei primi nella scuola, e che era amato da tutti.
Don Ropolo, di cui non so al presente il nome di battesimo, che dopo essere stato molti anni Vicecurato e beneficiato in Castelnuovo d'Asti fu poi Parroco a Mezzenile, defunto, mi disse che trovatosi egli nel Seminario di Chieri col Chierico Cafasso per due anni, il medesimo era il modello di tutti, distinto per pietà e per studio, tra circa ottanta compagni di Seminario. Don Monsello, compagno di corso, in questi tre anni, del Servo di Dio, mi disse pure che il medesimo era distinto per studio, e che, in occasione di una disputa in scuola, ordinata dal Professore, venne da questo esortato a non essere troppo arguto nelle sue argomentazioni.
Oltre ciò che ho già detto sulla pietà del Servo di Dio, aggiungo qui che il Canonico Gaude, Prevosto di Poirino, defunto, mi scrisse che aveva udito a dire in Cambiano che Don Dassano, Prevosto di Castelnuovo, nativo di Cambiano, ammirava le belle doti del Chierico Cafasso, le quali promettevano molto bene e che perciò lo aiutò nella sua carriera, con mezzi materiali. Lo stesso Don Dassano attestò in iscritto, che qui in originale rilascio come documento, che il Servo di Dio con ogni diligenza si comportò nelle vacanze dell'anno 1832 in ogni suo dovere da chierico, con piena sua compiacenza.
Il Síg. Don Siccardi, attuale Parroco di Provonda presso Giaveno, stato Vicecurato sotto il Teol. Arduino, che da Professore di Seminario a Chieri venne Prevosto e Canonico della Collegiata di Giaveno, mi disse che udì molte volte il suddetto Arduino lodare il Servo di Dio quale suo alunno in Chieri per lo studio.
Don Mansello, sopracitato, mi disse che il Professore Arduino suddetto, per la stima ed affetto che nutriva verso il Chierico Cafasso, si recò appositamente dalla campagna ove dimorava nel Seminario di Chieri per dare il suo voto fa vorevole per nominare il Chierico Cafasso ad uno dei tre Prefetti del Seminario. Don Ropolo, sopracitato e per la causa di scienza indicata, mi disse che il Chierico Cafasso era il più pacato dei compagni, che non prendeva parte ai divertimenti leciti ed onesti del Seminario, ma passeggiava con qualcuno e parlando di cose di studio e di pietà.
« PER DIVENIRE SOLO PRETE COME MIO PADRINO... »
Dai registri delle Confessioni del Seminario di Chieri sopraindicati, da me visti, mi consta che dopo avere nel principio del primo dei tre anni sopraindicati di Seminario in Chieri, provato due altri confessori, prese abitualmente per proprio il Canonico Maloria, il quale per giudizio datomi da Don Mansello era il più dotto dei Canonici di Chieri, e uomo di consiglio. Dal medesimo registro constatai che nei due primi dei detti anni si confessava non meno di ogni quindici giorni e spesso anche ogni otto, e nell'ultimo anno ogni otto giorni, eccettuate cinque volte, per motivo di sacre ordinazioni, e degli esercizi spirituali, nelle quali occasioni non si prendeva memoria delle confessioni. Notai ancora, nei detti registri, che tra i Chierici fu uno di quelli che si confessavano più sovente.
Don Allamano, già menzionato, mi disse che come compagno del Servo di Dio vide il medesimo nel primo anno di chiericato, studiando il secondo corso di filosofia in Chieri, a frequentare assiduamente la Parrocchia del Duomo per le funzioni, per le sacre cerimonie e vi faceva il catechismo, e la Congregazione del Collegio Civico predetto. Il medesimo Allamano mi raccontò che talora le funzioni della Parrocchia non terminando prima che incominciassero quelle della Congregazione, il Servo di Dio, sebbene accelerasse il passo, tuttavia vi arrivava in ritardo, del che in tali casi faceva le scuse al Prefetto della Congregazione, Don Marchisio, defunto, il quale non voleva sentire ragioni ed in fine del bimestre si rifiutò di sottoscrivergli l'admittatur. I professori (cioè il P. Sibilla, sovraccennato, ed altri che non mi disse) che molto amavano e stimavano il Servo di Dio, riferirono la cosa al Monsignor Colombano Chiaverotti, Arcivescovo di Torino d'allora, il quale per lettera riprese fortemente il prefetto: il quale prefetto, non so per quali motivi, venne anche destituito. Don Allamano non mi disse noi come avesse saputo tutto quest'ultimo fatto.
A questo punto, il testo esibisce al tribunale altri due documenti, cioè:
— una dichiarazione in dieci punti, rilasciata dalla Curia Arcivescovile di Torino il 1° febbraio 1897, dove sono segnate le tappe principali della vita di Don Cafasso a partire dalla sua nascita fino alla nomina a rettore del Convitto Ecclesiastico presso la chiesa di San Francesco d'Assisi in Torino, e ad amministratore del santuario di Sant'Ignazio sopra Lanzo, in data 6 dicembre 1848;
— l'attestato di buona condotta del prevosto di Castelnuovo, Bartolomeo Dassano, del 14 ottobre 1832.
Mia madre e mio zio Cafasso Pietro, defunti, ed altre persone del paese che non ricordo, mi attestano d'aver udito dal Servo di Dio appena fatto Chierico queste parole: per divenire solo prete come mio padrino non incomincio, e mi dicevano che con tali parole il Chierico Cafasso intendeva dire di non voler farsi solo sacerdote buono solo a dire la Messa ed il Breviario, come faceva detto padrino Don Musso, defunto, sacerdote alla buona, Cappellano della Confraternita del Nome di Gesù di Castelnuovo, che non mai si era abilitato alla Confessione e predicazione, perché di poco talento sebbene di buona condotta. Chiardi, già nominato, mi disse di aver visto che il Servo di Dio quando era Chierico viveva ritiratissimo ed il già detto Turco mi attestò che il Chierico Cafasso era veramente esemplare; mi soggiunse poi che ebbe dal medesimo in regalo due immaginette, una del Sacro Cuore di Gesù e l'altra del Sacro Cuore di Maria, che sempre conservò con amore e venerazione, perché regalo del Servo di Dio, né volle cedermele alle mie domande.
Don Allamano, sopradetto, mi disse che egli ed il Servo di Dio durante le vacanze d'ogni anno scolastico andavano a ripetizione dal Prevosto Don Dassano sopranominato, e che il Servo di Dio tutti i giorni nelle ore pomeridiane si recava a tener compagnia al predetto Don Musso, che l'aiutava a dire il Breviario, poi andava a far visita al SS. Sacramento, quindi si recava in casa parrocchiale a divertirsi cogli altri chierici, oppure insieme agli altri andava a passeggio. Non mi disse il modo come seppe queste cose, mi disse però che egli e gli altri chierici del paese erano uniti sempre assieme. Musso Paolo di Castelnuovo, vivente, mi scrisse che essendo egli in età di circa sette anni e trovatosi in casa di detto Don Musso, vide il chierico Cafasso a recitare il Breviario col Don Musso e rimase ammirato del buon contegno del Servo di Dio in quell'atto, e mi soggiunse che tale impressione gli si conservò sempre viva. Il medesimo mi aggiunse che il contegno del Chierico Cafasso metteva in certa soggezione il Clero del paese, come osservò egli stesso.
Cafasso Pietro, vivente, pronipote del Servo di Dio, mi disse di aver udito da sua nonna Anna Cafasso, cognata del Servo di Dio, il fatto seguente. Detta cognata accompagnava il fornaio che portava a casa la cesta del pane. Il Servo di Dio le veniva dietro e prendendo pane dalla cesta ne dava a quanti poveri incontrava. Di ciò accortasi la cognata un po' corrucciata esclamò: se fate così non resterà più pane. Ed il Servo di Dio a lei: lasciate, lasciate che Iddio ce ne darà cento volte tanto. So di certo dalla famiglia mia che il Servo di Dio viveva nella stessa casa con il fratello e quindi colla detta cognata.
Il Canonico Colombero, tuttora vivente, Curato di Santa Barbara, mi disse che avendo egli esaminato i registri dei Chierici del Seminario di Chieri, vi trovò che fu nominato Prefetto nell'ultimo anno di Teologia e che accanto al nome del Chierico Cafasso lesse l'appellativo di benemerito: nome che si dava assai di rado e solo ai chierici che si erano ben distinti in tutti i corsi per scienza e pietà.
TONSURA E ORDINI MINORI
Nel documento della Curia Arcivescovile che presentai nella seduta precedente mi consta che il Servo di Dio ricevette la Tonsura e Minori il 18 Settembre dell'anno 1830 in Torino da Monsignor Francesco Icheri di Malabaila, Vescovo consecrato di Casale.
Don Allamano e Don Ropolo, sopracitati, mi dissero che il Servo di Dio fu ordinato col patrimonio ecclesiastico costituito da un Beneficio semplice, detto Ghersi, del reddito annuo di lire seicento. Don Ropolo mi disse che egli seppe questo perché, essendovi annesse a quel Beneficio obbligazioni di Messe, quando Don Cafasso non poteva dir queste, le diceva egli stesso per incarico del Servo di Dio. Don Allamano non mi disse per qual ragione il Servo di Dio fosse provvisto di quel Beneficio. Don Monsello, vivente, mi disse di aver visto egli stesso il Servo di Dio nel Seminario di Chieri a recitare fin dal primo anno l'ufficio della Madonna, forse per motivo di detto Beneficio.
III - ORDINAZIONE SACERDOTALE
 Mi consta dal surriferito documento di Curia che il Servo di Dio fu promosso al Suddiaconato il 7 aprile 1832 da Monsignor Fransoni, Arcivescovo di Torino in Torino, ed al Diaconato il 23 marzo 1833 dallo stesso Monsignor Fransoni, Arcivescovo di Torino, in Torino, ed al Presbiterato il 21 settembre 1833 da Monsignor Giovanni Giuseppe Cavaleri, Vescovo di Bobbio, in Torino colle dispense dovute sopra gli interstizii e d'età.
Mi consta dal surriferito documento di Curia che il Servo di Dio fu promosso al Suddiaconato il 7 aprile 1832 da Monsignor Fransoni, Arcivescovo di Torino in Torino, ed al Diaconato il 23 marzo 1833 dallo stesso Monsignor Fransoni, Arcivescovo di Torino, in Torino, ed al Presbiterato il 21 settembre 1833 da Monsignor Giovanni Giuseppe Cavaleri, Vescovo di Bobbio, in Torino colle dispense dovute sopra gli interstizii e d'età.
Don Allamano, sopra nominato, mi disse che il Servo di Dio, in preparazione all'ordinazione della Messa, fece gli esercizi spirituali in privato presso il Canonico Cottino, Prevosto di Moncucco in Moncucco, per speciale permesso dei Superiori. Non mi disse come seppe questo. Mi aggiunse che vide il Servo di Dio a dire le prime Messe in Castelnuovo.
Fra gli scritti originali che tengo del Servo di Dio lessi le seguenti linee che possono dimostrare i sentimenti del Servo di Dio per le ordinazioni che ricevette: « Essendo per finire la mia missione, così scrive nell'esercizio mensile della buona morte, rendo e consegno al mio Dio quella grande vocazione di cui Egli ha voluto onorarmi. Io non ho termini quaggiù per ringraziarlo degnamente ed aspetto l'eternità ». Non sono informato come il Servo di Dio abbia esercitati i sacri Ordini ricevuti e specie come abbia detto la prima messa.
INCONTRO CON IL TEOLOGO LUIGI FORTUNATO GUALA
Don Allamano, suddetto, mi raccontò quanto segue: Ordinati sacerdoti, nello stesso anno, ma con diversità di pochi mesi, il Servo di Dio ed io, dovendo studiare la Morale Casuistica, verso la metà di novembre dell'anno medesimo 1833, andammo a Torino e prendemmo alloggio vicino alla Metropolitana in due camere procurateci dal Prevosto Don Dassano; ci facevamo portare il pranzo ogni giorno da una vicina locanda, ed alla sera ci facevamo noi stessi una minestra, ed il vino mandatoci dai nostri genitori ce lo portava dalla cantina un ragazzo, che in compenso veniva istruito da noi. Per l'assetto della camera la madre di Don Cafasso ci aveva procurato una donna che dopo poche volte licenziammo, non piacendoci il suo fare un po' troppo entrante. Andavamo al vicino Seminario Metropolitano frequentando le Conferenze morali del Canonico Fantolino. Ebbimo allora notizia che un Canonico della SS. Trinità (di cui non mi disse il nome) teneva pure Conferenze, e vi andammo più volte. Fu solo in quel punto che udimmo parlare delle Conferenze del Teologo Guala di recente fondate. Ci portammo una prima volta ad udirlo e ci piacque. Per mezzo del domestico del detto Teologo Guala (di cui non mi disse il nome) chiedemmo di parlare al detto Teologo per ottenere licenza di frequentare le sue Conferenze.
Il Guala in questo primo incontro, chiestoci il nome, manifestò di aver amicizia con un altro Cafasso, alla cui prima messa era intervenuto. Il Guala ci chiese dove abitassimo ed udita la nostra ingenua storia (che io ho esposto sopra), ne rise e ci disse che, se volevamo venire con lui nel suo Convitto, ci avrebbe accettati. Noi accogliemmo con gran piacere la proposta, e chiesti del quando, rispondemmo che anche quella stessa sera. Ne rise nuovamente il Guala, e ci accettò dicendo rincrescergli solo che, per allora, non aveva per loro che una stanza sola ed un solo letto. Pochi giorni dopo, essendosi resa disponibile un'altra camera ci fu assegnata anche questa, sicché ciascuno ebbe la propria camera.
Il giorno del nostro ingresso fu il 28 gennaio 1834 ed il Servo di Dio vi rimase per tutta la vita.
AL CONVITTO ECCLESIASTICO
Don Allamano, già più volte nominato, mi disse che il Servo di Dio, quando era con lui nell'alloggio comune vicino alla Metropolitana, dopo dette le orazioni della sera assieme, leggeva un capo della Sacra Scrittura e mi aggiunse che tale uso egli credeva che avesse già prima.
Dai registri del Convitto Ecclesiastico da me esaminati, trasportati dalla sede che aveva primitivamente, cioè dal Convento presso la Chiesa di S. Francesco d'Assisi, nel Convento della Consolata, dove è al presente, e di cui sono Rettore, consta che il Servo di Dio stette in Convitto come convittore i tre anni scolastici seguenti: dal 28 gennajo al giugno 1834; dal novembre 1834 al novembre 1835, eccetto un mese solo; e dal novembre 1835 al novembre 1836 senza interruzione. Dai medesimi registri mi consta che pagò sempre la pensione intiera di lire trenta mensili.
Il Canonico Bosso, poi Padre della Piccola Casa, defunto, mi scrisse che Don Cafasso entrato in Convitto condusse una vita tutta nascosta e di pietà, studiando profondamente la Morale Casuistica. Non mi disse il modo con cui seppe ciò.
Nel primo anno ebbe a compagno il Canonico Pelletta, vivente, e Don Allamano, defunto, sopradetto; nel secondo anno ebbe a compagno D. Bertolo Grato, Parroco attuale di Almese; nel terzo anno ebbe a compagno D. Gaia Luigi di Montà, defunto, ed il Teol. Golzio Fe lice, pure defunto, che fu poi il secondo do successore del Servo di Dio nel rettorato del Convitto. Tutto questo mi risulta dai registri succitati.
Il Canonico Pelletta mi attestò d'aver visto che il Servo di Dio era pio e molto mortificato, che, perché a lui vicino di studio, vedeva che si applicava seriamente allo studio, studiando il libro di testo allora adoperato in Convitto, che era la Teologia dell'Alasia e la Teologia Morale di S. Alfonso, e che prendeva note su fogli bianchi intercalati nel libro di testo. Mi aggiunse che egli ed il Servo di Dio, mandati dal Rettore Teologo Guala, andavano assieme a fare il catechismo nelle carceri della Città, nel quale atto lo osservò un po' sorridente, mentre ordinariamente era un po serio.
Don Allamano, suddetto, mi disse che vide che il Servo di Dio, mentre molti Convittori si facevano portare il caffè da un pubblico esercizio, prendeva solo pane.
Don Bertolo Grato, suddetto, mi disse quanto segue: Fin dagli anni del Convitto Don Cafasso era riguardato quale modello di virtù. Abitualmente raccolto in se stesso, era tutto dedito alla pietà ed allo studio, del quale si occupava con un compagno anche nel tempo di passeggio (e non mi disse il nome di questo compagno, perché non si ricordava più), osservava esattamente le regole, era parco e moderato nelle parole, rideva poco, aveva passo grave come ha un uomo serio e pensoso. Il suo volto era circondato da un'aria di bontà, che lo rendeva amabile ed ammirabile nell'aspetto, che non lo vide mai adirarsi; era sempre mansueto ed affabile con tutti, ma famigliare con nessuno; era da tutti cordialmente amato. Aggiunsemi che ricordava il suo speciale amore alle cose di Chiesa, la sua umiltà e la stima che indistintamente avevano di lui i Convittori come di un degno sacerdote. Lo stesso mi affermò essere andato col Servo di Dio nelle carceri a fare il catechismo.
Il Teologo Gaia Carlo, vivente, mi attestò che suo zio Don Gaia Luigi, suddetto, prevosto di Pocapaglia (Diocesi d'Alba), gli parlò molte volte con ammirazione e venerazione del Servo di Dio per la conoscenza che ebbe del medesimo quando gli fu compagno in Convitto, e morto il Servo di Dio, e vivendo egli parroco di Pocapaglia, ogni anno, finché visse, gli celebrava gratis un solenne funerale nella sua parrocchia per la buona memoria ed affezione che aveva per lui.
Don Momo Giuseppe, defunto, stato in Convitto per cinque anni dopo la morte del Servo di Dio, mi attestò che udì dal Teologo Golzio, Rettore, come Don Cafasso in qualità di Convittore, non solamente col Teologo Guala, ma ancora con tutti i compagni trattava con tale modesto contegno e parlava con tono sì umile e sommesso, da parere un religioso novizio, e che il Servo di Dio, essendo in refettorio accanto a Don Begliatti, assistente al tempo che il Servo di Dio faceva il terzo anno di Convitto, non avendo questi per quindici giorni rivolta una parola al Servo di Dio, esso Servo di Dio sempre si tacque, non tralasciando mai di levarsi la berretta di capo, con rispettoso inchino, al Don Begliatti, prima e dopo le refezioni.
Demolinis Carlo, domestico particolare del Teologo Guala in Convitto, morto poco fa, mi disse che vide il Teologo Guala a portare molto affetto al Servo di Dio come convittore e sentì il medesimo a dire del Servo di Dio: ho trovato un giovane che fa per me; se tutti fossero come lui andrebbero difilato in Paradiso; e che vide il Teologo Guala a far festeggiare da tutti i convittori lo splendido esame di confessione subìto dal Servo di Dio alla fine del terzo anno.
Dal documento rilasciato dalla Curia Arcivescovile, che presentai nella sessione 150a, consta che il Servo di Dio fu approvato per ricevere le confessioni e per l'ufficio di Vicecurato il giorno 27 giugno 1836, dopo subìto l'esame davanti ai Canonici della Metropolitana Perona e Zappata che lo dichiararono idoneo.
Don Giacomelli, vivente, mi disse che il Servo di Dio incominciò il ministero delle confessioni nella chiesa di S. Francesco d'Assisi, chiesa del Convitto, e nella festa dei SS. Pietro e Paolo di quell'anno 1836. Non mi disse come seppe ciò.
Nei tre anni che passò in Convitto, il Servo di Dio ebbe a Rettore il Teologo Guala, suddetto, che lo ricevette, e lo stesso come Capo di Conferenza Morale, ed a Ripetitori certi Don Marengo e Don Garabello, ora defunti, che allora avevano il titolo di prefetti. Ciò mi consta dai Registri del Convitto sopracitati.
INIZIA E CEDE A DON BOSCO L'OPERA DEI CATECHISMI
Il Servo di Dio, nel tempo che fu Ripetitore nel Convitto, catechizzava i ragazzi nella chiesa di S. Francesco come mi dissero Bargetto Giovanni e Felice Gaidano, viventi. Bargetto Giovanni, entrato in Convitto nel 1842 in qualità di garzone di cucina del Convitto e poi sacrestano della chiesa pubblica di S. Francesco, mi disse più volte che aveva visto tenersi i catechismi nella chiesa di S. Francesco e aveva visto il Servo di Dio a far il catechismo nella chiesa suddetta e propriamente nella cappella di S. Bonaventura; ed aveva pure visto che Don Bosco andava fuori di chiesa a raccogliere ragazzi e quindi, egli e Don Cafasso, fare il catechismo fino all'ora delle funzioni. Il Sig. Gaidano poi, entrato come domestico nel Convitto verso il 1850, mi assicurò d'aver udito, come voce comune in Convitto, che Don Cafasso, d'accordo col Teologo Guala, aveva preso a radunare ragazzi per catechizzarli nella retrosacrestia di S. Francesco; che ai medesimi regalava oggetti di vestiario, ecc. con denari ottenuti dal Teologo Guala. Mi disse ancora che in quell'opera si faceva aiutare da qualche convittore, fra cui Don Bosco, al quale poi rimise interamente l'opera quando, verso la fine del 1843, venne ammalato il Teologo Guala. Mi aggiunse che all'invito del Servo di Dio, Don Bosco oppose la difficoltà dei danari per i regali da farsi ai ragazzi; al che il Servo di Dio rispose: a questo penserò io. Mi conchiuse il Gaidano, che di tutto ciò si parlava fra loro domestici in Convitto come di cosa notoria.
Dietro queste affermazioni, parlando io con parecchi sacerdoti che venivano da me per riferirmi le loro attestazioni sul Servo di Dio, talora li interrogava sulle relazioni che passarono tra Don Cafasso e Don Bosco e mi sentiva rispondere che chi aveva incamminato Don Bosco e la sua Opera era Don Cafasso. Ricordo fra questi mio Zio Don Allamano, citato più volte, Don Allora Alessandro di Castelnuovo, defunto, Don Febbraro Stefano, Priore di Orbassano, defunto, Canonico Bosso, già menzionato, e Don Cocchis, defunto, fondatore degli Artigianelli di Torino. I tre primi come compaesani e quasi coetanei di Don Bosco, e gli altri due in Torino, in relazione con Don Cafasso e Don Bosco e Capi di Istituti.
Pubblicatasi dal Canonico Colombero la Vita del Servo di Dio nel 1895 ed iniziatosi il processo del medesimo, mi posi a far maggiori indagini per chiarire fatti e raccogliere nuove notizie. Ed in proposito dei catechismi interrogai di nuovo Bargetto e Gaidano, suddetti, separatamente, i quali mi risposero che erano fermi nel confermare quanto mi avevano già prima attestato quattro anni addietro.
Scrissi pure nel dicembre 1895 a Don Carena Biagio, attuale Vicecurato di Bra, ed al Teologo Peyretti Giuseppe d'Osasio, vivente, che furono in Convitto, il primo dal 1840 al 1843 ed il secondo dal 1840 al 1842, e mi risposero, il Don Carena che, per la sua avanzata età d'anni 76, si trovava assai privo di memoria, non si ricordava delle cose tutte di quel tempo ed in particolare riguardo alla mia speciale interrogazione sui catechismi, che gli pareva non si fosse accorto che si facessero detti catechismi né chi li facesse; ed il Teologo Peyretti che riguardo ai catechismi non sapeva neppure se si facessero, e che quindi non poteva dire da chi e da come.
Interrogai ancora Don Giacomelli, che fu convittore dal 1843 e 1845, e mi disse non ricordarsi d'aver visto Don Cafasso a fare il catechismo ai ragazzi in S. Francesco. Noto qui, che come mi disse Bargetto, i convittori erano proibiti di andare in sacrestia fuori delle ore delle funzioni, cioè la Santa Messa e Benedizione; che nell'andare al passeggio erano proibiti di passare, uscendo, per la porta della chiesa e della sacrestia, ma dovevano solo passare per la portineria. Noto ancora che se la deposizione dei testi che non videro a far il catechismo valesse, ne seguirebbe che neppure Don Bosco, convittore negli anni dei testi sopracitati, non avrebbe fatto anche lui catechismo in S. Francesco; il che è contrario a quanto unanimemente afferma la voce pubblica. Lessi poi nella Biografia del Servo di Dio, scritta da Don Bosco e che presenterò più tardi, che lo stesso Don Bosco confessa che Don Cafasso fu il primo catechista dell'Oratorio.
Dalla relazione scritta che mi pervenne da Don Savio Ascanio, Rettore attuale del Seminario di S. Gaetano, che sebbene di presente sia indebilitato di mente, quando mi scrisse la relazione era nel pieno possesso delle sue mentali facoltà, mi risultano varie cose intorno all'Oratorio di Bon Bosco ed all'opera prestatavi da Don Cafasso. Domando al Tribunale di poter presentare la detta relazione insieme ad altre, che in seguito dovrò citare in fine delle sessioni per gli interrogatorii cui sarò sottoposto, trovandosi in esse relazioni molte cose che non riguardano questo Interrogatorio.
IV - ALTRE RELAZIONI CON DON BOSCO
Don Momo Giuseppe, suddetto, mi scrisse di aver udito dal Teologo Borel, defunto, che Don Cafasso pagava al medesimo Teologo Borel, Rettore del Rifugio, la pensione per Don Bosco presso di lui, finché Don Bosco stesso non fu nominato cappellano del Rifugio, e che il Servo di Dio un giorno si portò al Rifugio per impedire a Don Bosco di partire da Torino, essendoché Don Bosco, ignaro del pagamento della sua pensione fatto da Don Cafasso e credendosi perciò di peso al Borel, non voleva più abusare della costui ospitalità e quindi voleva partire da Torino. Don Cafasso, il 29 maggio 1845, per ottenere l'appoggio del Conte Bosco di Ruffino scrisse alla Contessa sua consorte onde ottenere dalla Città di Torino che fosse nominato Don Bosco a Cappellano del cimitero e chiesa di S. Pietro in Vincoli. Questa lettera io la lessi e la tengo in mie mani.

Don Bosco, terminati i tre anni di Convitto, doveva uscirne per occuparsi come Vicecurato, e vari parroci lo desideravano: fra gli altri Don Giuseppe Comollo, Rettore di Cinzano, defunto, il quale lo aveva chiesto ad amministrare in sua vece questa parrocchia e ne aveva già avuto il consenso da Mons. Arcivescovo Fransoni; era pure chiesto come Vicecurato dal Parroco di Buttigliera d'Asti. Don Cafasso allora lo chiamò a sé e, fattegli presenti quelle domande, gli chiese il suo sentimento in proposito. Don Bosco rispose che propendeva ad occuparsi della gioventù, ma che si rimetteva alla sua decisione, sicuro di fare la volontà di Dio. Allora Don Cafasso lo mandò in vacanza dicendogli di tornare da lui dopo qualche settimana. So questo per averlo letto nella storia dei cinque lustri dell'Oratorio Salesiano scritta da Don Bonetti, stampata dalla Tip. Salesiana in Torino, cap. 4 pag. 289.
Tornato a Torino in Convitto, Don Cafasso gli procurò quella pensione presso il Teologo Borel, come dissi poco sopra.
La casa Pinardi, che fu la prima comperata per l'Oratorio Salesiano, situata in Valdocco, fu comprata da quattro insieme, cioè Don Bosco, Teol. Borel, Murialdo e Don Cafasso con istrumento del 19 febbraio 1851, rogato Notaio Turvano, al prezzo ivi scritto di lire ventottomila e cinquecento, delle quali ottomila cinquecento si obbligarono, come si accen , na in detto istrumento, tutti quattro per iscrittura privata verso certo Pinelli, le altre ventimila presero ad imprestito dall'Abate Antonio Rosmini, dandogli ipoteca sullo stabile, all'interesse del 4% colla mora di otto anni. Con altro istrumento 'del 26 gennaio 1853, l'obbligazione verso Rosmini fu assunta tutta da Don Cafasso e Don Bosco, la quale obbligazione fu poi estinta così: lire quindicimila furono pagate al Padre Bertetti, successore di Rosmini nell'Istituto della Carità, con atto 11 marzo 1859, dove è detto che Don Bosco paga con danaro comune al Sig. Don Cafasso. Io non lessi i citati istrumenti, ma ne ebbi le notizie suesposte dal Teologo Bertolone Giacomo, già Postulatore di questa Causa, che li lesse dietro mio incarico. Delle restanti cinquemila non sono stato informato. Dall'esame dei registri del Convitto mi risulta che Don Bosco, nei tre anni che dimorò in esso, godette di una speciale carità del Convitto. Il 1° anno il Convitto supplì alla sua pensione per lire settantadue; nel 2° per lire novantasei; e nel 3° per lire cento settantatre e sessanta centesimi. Penso per raccomandazione di Don Cafasso presso il Teologo Guala.
Don Bosco fu più volte udito a dire con espressione di profonda gratitudine: se io ho fatto qualche cosa di bene, lo debbo a questo degno ecclesiastico (Don Cafasso), nelle cui mani rimisi ogni mia deliberazione, ogni studio, ogni azione della mia vita. Queste parole ho lette nella menzionata storia di Don Bonetti (pag. 17) e le ho sentite da Mons. Appendini, Beneficiato a Villastellone, che le udì da Don Bosco medesimo.
Lessi nel testamento del Servo di Dio al N. 14 le seguenti parole: lascio al sacerdote Don Bosco Giovanni di Castelnuovo d'Asti e domiciliato in Torino quanto è di mia proprietà nel sito e fabbrica attigua all'Oratorio S. Francesco di Sales in questa Capitale, regione Valdocco, coll'aggiunta di lire cinquemila per una volta tanto. Condono al medesimo quanto fosse per essere debitore verso di me al mio decesso, lacerando perciò e rimettendogli ogni memoria in proposito.
Il Bargetto, sopracitato, mi espresse la sua indignazione perché, collocatasi una lapide nella sacrestia di S. Francesco, in essa non si fa memoria del Teologo Guala e di Don Cafasso. La lapide porta la seguente iscrizione che lessi: Qui addì 8 dicembre 1841 sacro all'Immacolata Concezione il sacerdote Giovanni Bosco dava principio alla pietosa missione a vantaggio della gioventù l'Unione Cattolica Operaia di Torino nel cinquantesimo anniversario a perpetua memoria questa lapide pose.
PREFETTO DELLE « CONFERENZE DI MORALE »
Nei registri del Convitto già sopra indicati lessi che Don Cafasso fu eletto Prefetto e Ripetitore fin dal 1° ottobre 1836, cioè poco prima dell'apertura dell'anno scolastico. Il Canonico Bosso, già più volte menzionato, mi scrisse che il Servo di Dio, carissimo al Teol. Guala, venne da lui eletto a Ripetitore. Divenuto dopo alcuni anni il Teol. Guala infermiccio, confidò pure a Don Cafasso la conferenza pubblica, nel quale ufficio il Servo di Dio apparve fornito di doni singolari onde il Teologo Guala inviava a lui tutte le sue pratiche col motto Ite ad Joseph. Non so come il Can.co Bosso abbia ciò saputo.
Don Garigliano Guglielmo, vivente, che dimorò in Convitto dal novembre 1842 al giugno 1846, mi scrisse che vide che il Teol. Guala, ammalatosi verso la fine del 1843, si fece supplire nella Conferenza della sera (cioè la pubblica) da Don Cafasso, continuando pure il Servo di Dio a far la ripetizione al mattino. Il Sig. Brogino Giuseppe, defunto, mi disse di aver udito più volte a dire, non so da chi, che il Teologo Guala si compiaceva di Don Cafasso. In prova di ciò lessi nel testamento del Teologo Guala del 21 giugno 1848 le seguenti parole: Istituisco e nomino in mio erede universale il Signor Sacerdote Don Giuseppe Cafasso... Istituisco una Cappellania all'Altare del Crocifisso coll'obbligo all'investito d'una messa mensile e dell'assistenza al confessionale quattro giorni ogni settimana. Nomino Cappellano di detto Beneficio (con diritto di eleggersi il successore) Don Giuseppe Cafasso, il quale pel conosciuto suo zelo, dottrina e pietà, dispenso dall'osservanza degli obblighi imposti, sapendo non aver esso bisogno di alcuno stimolo per conformarsi alla mia volontà.
Nel documento inserito nella sessione 150 sta scritto che il Servo di Dio fu nominato 1° Rettore della Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Torino e della Congregazione degli Artisti con Decreto Arcivescovile del 6 dicembre 1848, nel qual Decreto è detto che egli è commendato religiosa benignitate, animarum zelo, doctrina, sacerdotali gravitate et aedificante conversatione; 2° fu eletto Rettore del Convitto Ecclesiastico di S. Francesco d'Assisi in Torino con altro Decreto del 6 dicembre 1848, nel quale è lodata fides, probitas, dottrina, prudentia et zelus del Servo di Dio; 3° che fu deputato Amministratore del Santuario di S. Ignazio presso Lanzo Torinese con altro decreto arcivescovile del 6 dicembre 1848. In tutti e tre i Decreti io lessi la qualifica attribuita al Servo di Dio di Esaminatore Prosinodale.
L'INSEGNAMENTO
DELLA TEOLOGIA MORALE
In proposito all'insegnamento come Ripetitore e come Capo di Conferenze, dico in prima le notizie che ho potuto ricavare a voce parlando con alcuni suoi alunni e poi addurrò relazioni scritte che ebbi da altri alunni di lui.
Don Cocchis, già nominato, mi disse che Don Cafasso era un uomo d'ingegno e nutrito di forti studi e che fu egli, che veramente fece conoscere le dottrine di Sant'Alfonso. Come ciò abbia saputo io non so precisamente dirlo, perché non so positivamente che abbia frequentato la conferenza del Servo di Dio.
Il Canonico Martini, vivente, che mi disse essere intervenuto alle Conferenze del Servo di Dio, mi attestò che alle medesime accorrevano sacerdoti giovani e vecchi da non potersi talora contenere nel gran salone. Prudentissimo, non parlava mai di politica, era chiaro e sempre pronto alle nostre domande.
Don Sassi Giuseppe, convittore dal 1839 al 1841, come lessi nei Registri del Convitto, defunto, mi fece scrivere dal Teol. Ferrero Michele, vivente, che vide il Servo di Dio nella Conferenza che proposto un caso di morale interrogava alcuni Convittori a scioglierlo. Siccome i casi non erano tanto facili, gli scolari qualche volta facevano tali confusioni da non più capirsi alcuna cosa, e le risoluzioni venivano diverse e anche opposte. Sottentrava poi egli con parola calma e franca e distinte le questioni appartenenti al caso, le scioglieva una ad una secondo i principii tanto chiaramente che tutti ne rimanevano stupefatti, e potevano facilissimamente ricordare le soluzioni. Don Berardi Pietro, defunto, allievo delle Conferenze del Servo di Dio, non ricordo in quali anni, mi scrisse che il Servo di Dio nel fare le conferenza era sempre di animo pacato, tranquillo, benigno, condiscendente alle obbiezioni e rispondeva con tale chiarezza di idee da far meraviglia.
Mons. Appendini, già nominato altra volta, mi fece scrivere dal prevosto di Villastellone Teol. Aghemo Giovanni, vivente, per impotenza di scrivere egli stesso, che Don Cafasso con una virtù che resisteva a tutte prove, con calma prodigiosa, con un'accortezza e prudenza ammirabili, con una pietà esimia e ad un tempo facile e modesta, fece scomparire affatto quell'acrimonia che in alcuni probabilioristi ancora rimaneva contro i Liguoristi, e cooperò efficacemente a formare un clero dotto ed esemplare. — Egli non fu convittore, né so io come il medesimo abbia ciò saputo, so solo che era molto in relazione coi Superiori del Convitto come egli stesso mi disse.
Dalla voce unanime degli allievi del Servo di Dio che interpellai so che il libro di testo dell'insegnamento durante la vita del Servo di Dio era la Teologia Morale del Teologo Alasia, in quattro volumi. Tengo del Servo di Dio detto testo legato in undici volumi con fogli bianchi intercalati ad ogni foglio stampato. Su questi fogli bianchi il Servo di Dio scrisse molte note ed appunti ricavati dai migliori autori di morale, cioè S. Alfonso, Suarez, De Lugo, Lessio, Salmanticesi, Sporer, Reuter, Billuart, Tournely, Sanchez, Vasquez che egli cita ivi ecc. So questo perché conosco che la scrittura è proprio quella del Servo di Dio. lo che esaminai e studiai questi scritti di lui, trovai che il Servo di Dio ricavò dai sopradetti autori il meglio e ciò che era più pratico in essi, seguendo in ciò l'uso praticato da S. Alfonso nella sua Teologia Morale, conchiudendo sempre con norme pratiche secondo i diversi stati dei penitenti. — Dalla diversità di inchiostro e dal diverso modo di scrivere rilevai che questo lavoro incominciato da Convittore, come mi attestò il Canonico Pelletta, fu proseguito fino ai suoi ultimi anni.
Da questi scritti il Servo di Dio trasse un Compendio della Morale tutta, che passò sotto il nome di Trattatelli di Don Cafasso che gli allievi copiavano a gara. Sentii a dire, non ricordo più da chi, che il Servo di Dio, invitato a stampare detti Trattatelli, disse che l'avrebbe fatto se avesse ancora avuto tre mesi a sua disposizione.
Da una lettera scritta dal Servo di Dio al Teologo Eusebio Lebole, defunto, che posseggo, del 14 ottobre 1844, rilevo che il Servo di Dio spedì al medesimo le parti dei Trattatelli r de praeceptis Decalogi et Ecclesiae; 2° de Contractibus in genere et specie; 3° de Virtutibus Theologicis; soggiungendo che il trattato de Iustitia etIlure doveva ancora formarlo secondo le nuove leggi, e che non gli era ancora stato possibile comporre i Trattati de Matrimonio e de Simonia.
Nelle Conferenze Don Cafasso dal 1847 al 1860 dettava casi di Morale, in media circa 25 all'anno, dei quali io posseggo in originale N. 290. So questo perché posseggo i manoscritti originali del Servo di Dio. Non so poi quanti casi abbia dettati negli anni precedenti perché non ne ho gli originali. Tuttavia dalle copie, che posseggo, deduco che ne dettava anche negli anni precedenti ed in pari numero annuale. Dalla voce unanime dei Convittori da me consultati, allievi del Servo di Dio, mi consta che il medesimo usava, ogni sera se non erro, nella Conferenza pubblica far proporre una confessione pratica, a cui designava uno a far da confessore, conchiudendo poi egli col sciogliere le difficoltà proposte, e sopra tutto, come mi disse il Can.co Roetti allievo pure di lui, dava norme pratiche a saper prendere e dirigere le persone secondo i diversi stati e qualità loro particolari. Lo stesso Can.co Roetti mi disse che il Servo di Dio parlava colla massima delicatezza della materia de sexto, però quanto era necessario per formare idonei Confessori, dicendo che studiata questa materia secondo il debito, indicato dalla prudenza di Don Cafasso, si sarebbero risparmiate in confessionale molte domande imprudenti e con poche interrogazioni avrebbero i confessori capito il necessario per l'integrità.
La dottrina morale insegnata dal Servo di Dio fu precisamente quella di S. Alfonso de' Liguori, seguita però non materialmente, ma nello spirito secondo il sistema del medesimo santo. Ciò mi risulta dalla lettura dei suoi manoscritti che conservo.
Nelle relazioni che addurrò in seguito si trova un qualche cenno più o men lungo dell'insegnamento di Morale fatto dal Servo di Dio. Rilevo dai manoscritti del Servo di Dio originali, che posseggo, che egli dal 1845 al 1860 dettò tredici casi per concorso a parrocchie dell'Arcidiocesi, e quindi da quell'epoca era Esaminatore Prosinodale.
SUPPLISCE IL GUALA NELLA DIREZIONE
Il Servo di Dio fu Rettore del Convitto dall'anno 1848, come risulta dal documento presentato. Però per motivo di malattia del Teologo Guala, a cominciare dalla fine del 1843, come suppliva il Guala nella Conferenza pubblica così l'aiutava ed anche suppliva nella direzione del Convitto e della Chiesa. Provo ciò 1° da ciò che mi scrisse Don Garigliano, soprannominato, il quale fu presente nei 4 anni scolastici che dimorò in Convitto. Egli mi scrisse che durante i suoi studi nel Convitto potè conoscere il Servo di Dio quale sacerdote esemplare, sempre uguale a se stesso, pieno di umiltà, molto pio e zelante della gloria di Dio. Desideroso io, soggiunge, di essere collocato quale cappellano presso qualche famiglia, fui consigliato da Don Cafasso a rimanere in Convitto come feci e durante le vacanze mi mandava a frequenti passeggiate ed in fine mi regalò una discreta somma di danaro. Il medesimo Don Cafasso nella primavera del 1845 mi mandò a celebrare messa dalle Forzate. Io poi ammirai, continua il medesimo, nel Servo di Dio una grande prudenza nel dar consigli, seguendo i quali mi trovava sempre soddisfatto, buona volontà, santi propositi e ottime disposizioni nell'educazione dei Convittori. Provo 2° da due lettere del 1844 dirette al Teologo Lebole, defunto, scritte dal Servo di Dio, nelle quali dice di accettarlo in Convitto; queste lettere sono nelle mie mani. 3° dal Conte Saverio Provana di Collegno, vivente, il quale mi scrisse che il Teologo Guala verso il 1844, non potendo più attendere al Confessionale, indirizzò lui a Don Cafasso e che così fecero pure suo padre ed i suoi congiunti e continuando a confessarsi dal Servo di Dio fino alla morte del medesimo.
Seppi dal Teologo Boccardo Luigi, uno dei Superiori attuali del Convitto, a cui parlò il Canonico Delbosco Lorenzo, defunto, il quale fu Convittore, come vidi nei registri, nell'anno scolastico 184647, che Don Cafasso in quell'anno per prima cosa insegnò ai Convittori di far bene il segno della Croce; e che il Servo di Dio non voleva che a tavola i Convittori si dessero vicendevolmente vivande o vino.
Inoltre per quanto il Servo di Dio fece nella sua qualità di supplente nel reggere il Convitto sino alla morte del Guala, produco le relazioni di Don Sassi Giuseppe, defunto, Convittore negli anni 1839-40 e 1840-41; Canonico Barbiè Felice, defunto, Convittore nell'anno 184041; Don Bosio Antonio, defunto, parroco di Levone, Convittore negli anni 1844-45 e 1845-46.
V - RETTORE DEL CONVITTO ECCLESIASTICO
 Fatto rettore del Convitto alla morte del Teologo Guala, il Servo di Dio si regolò nel seguente modo. Mons. Bertagna, vivente, mi disse che il Servo di Dio durante le vacanze faceva uno studio speciale sul Regolamento del Convitto e vi introduceva talora qualche piccola variazione di qualche piccola parola o simili. E mi soggiunse che i Convittori sapevano tale cosa, per cui ritornati in Convitto ansiosi si portavano a verificare i fatti cambiamenti. Ciò vide egli stesso, perché uno dei Superiori del Convitto al tempo di Don Cafasso.
Fatto rettore del Convitto alla morte del Teologo Guala, il Servo di Dio si regolò nel seguente modo. Mons. Bertagna, vivente, mi disse che il Servo di Dio durante le vacanze faceva uno studio speciale sul Regolamento del Convitto e vi introduceva talora qualche piccola variazione di qualche piccola parola o simili. E mi soggiunse che i Convittori sapevano tale cosa, per cui ritornati in Convitto ansiosi si portavano a verificare i fatti cambiamenti. Ciò vide egli stesso, perché uno dei Superiori del Convitto al tempo di Don Cafasso.
Che durante il Rettorato del Servo di Dio vigesse la disciplina in Convitto mi consta da una lettera del Teologo Golzio, defunto, secondo successore del Servo di Dio, diretta al Vicario Capitolare Can. Zappata nell'anno 1870, lettera, che conservo, nella quale dice di non esservi più quel fondo di studio, di disciplina, di interno andamento e regolarità come ai tempi del Teologo Guala e di Don Cafasso, che avevano cotanto innalzata la considerazione di questa Casa.
Don Allamano, già soprannominato, mi disse che il Servo di Dio era rigoroso nell'osservanza della disciplina, e che licenziò qualche convittore che aveva risposto malamente al comando di un superiore. Come ciò abbia saputo non so. Il Canonico Roetti, defunto, Teologo Collegiato, Professore di Teologia in Seminario, Provicario Generale, Padre della Piccola Casa, Canonico della Metropolitana, mi disse che trovandosi in Convitto ed alle conferenze vide che il Servo di Dio si serviva delle conferenze per dare avvisi ed ammonimenti a loro Convittori per formarli nello spirito ecclesiastico e buoni e zelanti sacerdoti. Mi risulta dalla Biografia del Servo di Dio scritta da Don Bosco, che presenterò, che il Servo di Dio dava ai Convittori esempio di regolarità a tutte le pratiche del Convitto.
Il Canonico Colombero, vivente, che fu Convittore per un anno, se ben ricordo nel 1858, mi disse che il Servo di Dio faceva studio speciale dei Convittori, della loro indole ecc. e mi portò per esempio se stesso, il quale, come timido, credeva di non essere stato conosciuto dal Servo di Dio, ma invece ebbe prova in seguito di essere stato bene conosciuto dal Servo di Dio. Da un manoscritto del Servo di Dio, che tengo presso di me, mi risulta che per infondere nel Convittori amore, attaccamento e sommissione alla Santa Sede faceva leggere in Refettorio dall'anno 1849 al 1860 le Vite dei Sommi Pontefici Innocenzo III e Gregorio VII, il viaggio di Pio VII del Cardinal Pacca, la storia di Bonifacio VIII, la vita di S. Pio V, la storia delle avversità di Pio VI, tutte opere di autori schiettamente Cattolici, eccetto l'Hurter, che benché protestate, ha difeso egregiamente il Papa Innocenzo III, e per vari anni di seguito la Storia Universale della Chiesa Cattolica dell'Abate Rohrbacher, del quale, secondo che mi attestò Don Rolando Prevosto di Pessinetto, allora Convittore, di cui non ricordo il nome, di aver udito dal Servo di Dio l'espressione: se tale autore non avesse fatto altro che scrivere questa storia, per ciò solo doveva avere un gran premio in Paradiso. In aggiunta al detto sin qui circa il Rettorato del Servo di Dio produco le relazioni scritte di Don Martino, defunto Prevosto di Piscine, che fu Convittore nel 1848-49 e 1849-50; Don Prato, Parroco defunto di S. Giovanni di Savigliano, Convittore nel 1854-55; Don Tonietto, Prevosto defunto di Monasterolo di Savigliano, Convittore nel 1854-55 e 1855-56; Don Baravalle Ferdinando, Parroco defunto di Mathi Canavese, Convittore nel 1856-57 e 1857-58.
RETTORE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
Venendo a parlare del Servo di Dio come Rettore della Chiesa di S. Francesco d'Assisi, so dal Signor Bargetto, sacrestano di detta Chiesa sotto il Servo di Dio, che Don Cafasso poneva mente a quanto si faceva in Chiesa e voleva che gli altari fossero ben puliti, sicché, ogni volta che ritornava dal confessionale passando in sacrestia, il Bargetto si aspettava di udire qualche osservazione intorno al decoro della Chiesa. Il medesimo Bargetto mi aggiunse che nelle solenni Quarantore Don Cafasso veniva a vedere l'apparato, che egli stava preparando, e se vedeva che c'era ancor posto per candele, gli ordinava di aggiungerne quanto più potesse. Lo stesso mi attestò che il Servo di Dio gli espresse l'idea di far abbellire la Chiesa, e seppe, credo da Monsignor Galletti primo successore di Don Cafasso, che il Servo di Dio aveva lasciato una somma a questo scopo; che se ben ricordo, era di lire cinquemila.
Il Canonico Gaude, defunto, già nominato, mi scrisse che, essendo egli confessore nella Chiesa di S. Francesco nel 1855, soleva porre il fazzoletto bianco pendente sul davanti della porticina del confessionale, il Servo di Dio per correggerlo gli disse sorridendo: fa asciugare il bucato? Premetto che la Chiesa di S. Francesco non essendo parrocchia non [vi] si predicava regolarmente come nelle parrocchie. Tuttavia so dal Bargetto suddetto che il Servo di Dio vi predicò l'annuale forse nel 1846, e che vi predicava in mancanza di qualche predicatore invitato, per novene e simili. Ciò vide perché sacrestano. Mi raccontò ancora che una volta lo vide ascendere in pulpito dopo pochi minuti di preghiera, essendo mancato il predicatore all'ultimo momento, nella novena del SS. Natale. Che il Servo di Dio predicasse in S. Francesco mi risulta pure da varie prediche manoscrittte del Servo di Dio che conservo, contenenti accenni, da cui si rileva che furono fatte in detta Chiesa. Non so con qual successo né con qual profitto degli uditori: solo udii dallo stesso Bargetto che la suddetta predica della novena del Santo Natale piacque tanto che don Cafasso fu pregato da varie persone di continuar lui la novena. Non so come Bargetto abbia saputo questo.
DON CAFASSO CONFESSORE. LUNGO ELENCO DI PENITENTI
Ho già riportato sopra le parole del Teologo Guala, dove nominando il Servo di Dio al Beneficio del Crocifisso, a cui aveva annesso principalmente l'obbligo di confessare, lo dispensò da quest'obbligo sapendo non aver esso bisogno di alcun stimolo per conformarsi alla sua volontà. Questo prova già la sua diligenza al Confessionale.
Inoltre questa sua diligenza viene confermata da quanto scrisse Don Bosco nella citata Biografia del Servo di Dio, e dalla relazione di mons. Galletti che presento.
La Damigella Garneri Maria, defunta, che fu penitente del Servo di Dio dal 1854 fino alla morte di lui, mi disse che il Servo di Dio non era lungo nel confessare, che aveva poche parole, ma queste bastavano a persuadere e tranquillizzare, a togliere tutti i dubbi e tutte le pene. La medesima mi aggiunse che, di tante tribolazioni spirituali che essa aveva, non ne sentì più il peso dalla prima volta che si confessò dal Servo di Dio fino alla morte di lui, e lo sentì nuovamente dopo questa. Mi disse ancora che il Servo di Dio per lo più in penitenza dava atti di amor di Dio, e conchiuse con dirmi che quel confessionario nessuno dovrebbe più usarlo, ma dovrebbe custodirsi come una Reliquia, dacché è veramente di un santo.
Mi dissero essi stessi che si confessarono dal Servo di Dio il Conte e Generale Incisa Beccaria Belbo Luigi, vivente; il Cav.re Michelangelo d'Agliano, vivente; il Commendatore Vezzosi, vivente; la signora Clerico, vivente; Don Bosco, fondatore dei Salesiani, defunto, il quale mi disse di essere stato l'ultimo a confessarsi dal Servo di Dio già ammalato dell'ultima infermità; il Barone Feliciano Ricci des Ferres, defunto; la Marchesa Maria Fassati, vivente, i quali tutti me ne parlavano come di un espertissimo direttore di coscienza, di cui erano soddisfattissimi; ed in particolare la signora Clerico mi disse che il Servo di Dio l'animava alla confidenza in Dio in mezzo alle sue tribolazioni, dicendole che anche per lei c'era un posto in Paradiso; il barone Ricci mi disse che dopo la morte del Servo di Dio, lamentandosi con Don Bosco di tal perdita, ebbe da lui questa risposta che un direttore simile non l'avrebbe più trova to in sua vita.
Inoltre seppi dal Teol. Giuganino Bartolomeo, vivente, che il Marchese Cusani, vivente, gli disse essere stato solito a confessarsi dal Servo di Dio e che ne era entusiasmato; seppi pure dalla Giacinta Malerba, defunta, cameriera della Contessa Sabina Ricardi Casassa, che questa le disse che si confessava da Don Cafasso, e che ne era contenta e che la tranquillizzava mirabilmente. La stessa cosa si legge nell'attestazione, già presentata da me, scritta da Monsignor Galletti. Nella vita della Marchesa Giulia Falletti di Barolo, stampata dalla Tipografia Speirani, composta dal Canonico Lanza Giovanni, Professore, leggo quanto segue: Don Cafasso era [confessore] ordinario della Marchesa (di Barolo).
Il Conte Ottavio Bosco di Rullino, vivente, mi disse che sua madre e sua sorella, la quale fu poi Suora della Visitazione in Torino, tutte due defunte, si confessavano dal Servo di Dio e mi aggiunse per iscritto, che le medesime avevano una fiducia illimitata e ben giusta in ogni sua parola, e che fu da esse molto rimpianto.
Genolino Clara, in religione Suor Brigida, defunta, che fu poi Superiora delle Carmelite in Cavoretto, e delle Taidine, entrambe istituzioni del Venerabile Cottolengo, si confessava da Don Cafasso e fu dal medesimo indirizzata alla Piccola Casa, come essa stessa mi disse.
Le sorelle Bellingeri Irene e Maria, viventi, mi dissero che si confessavano dal Servo di Dio e della sua direzione erano molto soddisfatte.
La Damigella Bosio Angela, vivente, mi disse che si confessava pure dal Servo di Dio, e la sapeva tranquillare nelle sue pene spirituali.
Il Canonico Giordano, illustre predicatore di Torino, e uomo stimato per la sua santità, defunto, si confessava dal Servo di Dio, come rilevo dall'espressione usata da lui in una sua predica negli esercizi spirituali al Clero, stampata dalla Tipografia degli Artigianelli di Torino, col titolo: Esercizi spirituali al Clero, dove chiama il Servo di Dio suo padre e sé suo povero figlio spirituale. E mi pare che il Can.co Nasi, vivente, mi abbia detto che il Can.co Giordano era effettivamente penitente di Don Cafasso. Aggiungo ai nomi dei penitenti del Servo di Dio ancora i seguenti.
Il Commendatore Crodara-Visconti Giacinto, vivente, mi disse che si confessava dal Servo di Dio e ne ha tuttora la stima come di un santo. La Damigella Garneri Maria, defunta, mi disse che si confessava dal Servo di Dio, a ciò invitata dal fratello Chierico, e mi narrò che la dirigeva così bene nelle cose anche piccole, da farle venire un gran desiderio del Paradiso; e con una corona particolare con grani scorrevoli le faceva contare le piccole mortificazioni, talora fino a 50 al giorno.
Don Tarizzo Giuseppe, Pievano attuale di Rivara, mi disse che si confessava dal Servo di Dio, e che gli inspirava sentimenti di vero spirito ecclesiastico e di amore alla Santa Sede. Dal Sig. Bargetto, più volte citato, seppi che egli vide il Servo di Dio a confessare abitualmente nel confessionale secondo di sinistra di chi entra in Chiesa di S. Francesco, e che tenne tale confessionale sino alla morte, sebbene fosse esortato a prenderne un altro più vicino alla sacrestia e quindi più comodo, e che volle tenere il primo per dare maggior comodità ad ogni sorta di gente per venire a confessarsi, massime ai più restii a confessarsi. Il medesimo mi disse anche che vide il Servo di Dio a confessare molti uomini nella sua camera specialmente di sera e verso notte. Così mi dissero che si confessarono in camera del Servo di Dio il Cavaliere Michelangelo d'Agliano, il Commendatore Vezzosi, il Commendator Cordara ed altri che non ricordo.
Certa Bolla Angelina, abitante ora in Sardegna, vivente, mi scrisse che un giovane di ventisei anni, dato alla vanità del mondo, venuto in fin di vita desiderava di avere Don Cafasso ad assisterlo nelle sue agonie. Chiamato il Servo di Dio dalla famiglia, colla sua affabilità vi andò e vi stette per varie ore fino alla morte, aiutandolo con tanta carità a morir rassegnato. Non mi scrisse chi fosse questo giovane né come seppe il fatto che lo riguarda.
VI - CONTINUA L'ELENCO DEI PENITENTI
 La Damigella Orsi Carolina, vivente nel Convitto delle Vedove e Nubili in Torino, mi raccontò che vide il servo di Dio andare colà dal Convitto per confessare certa Gerbino, di lui penitente, inferma; e che quando non poteva assolutamente andare, egli vi mandava il Teologo Golzio. Detta Gerbino ora è defunta.
La Damigella Orsi Carolina, vivente nel Convitto delle Vedove e Nubili in Torino, mi raccontò che vide il servo di Dio andare colà dal Convitto per confessare certa Gerbino, di lui penitente, inferma; e che quando non poteva assolutamente andare, egli vi mandava il Teologo Golzio. Detta Gerbino ora è defunta.
Suor Rosa delle Giuseppine, maestra nel Monastero delle Orfane di Torino, mi raccontò che certa Maggia Giuseppa, orfanella, defunta, ivi ricoverata, era talmente affetta da pene e scrupoli che per farla comunicare a Pasqua ed a tempo ben inoltrato, si esigeva sempre tutta l'autorità di un confessore speciale. Un anno per consiglio di Monsignor Ceretti venne pregato Don Cafasso, il quale la confessò in poco tempo, mentre con altri era necessario gran tempo, ed aspettò l'indomani a far la Santa Comunione, che poi fece senza essere trascinata, come le altre volte, senza nuovamente riconciliarsi: due fatti questi che furono tenuti come straordinari nella Comunità, e che non successero mai né prima né dopo d'allora, e attribuiti allo spirito del Servo di Dio. La detta Suora seppe ciò, come mi disse, dalle orfane anziane, compagne della Maggia, e delle quali alcune sopravvivono ancora.
Certo Giaccardi Giovanni, sacrestano della chiesa della SS. Trinità in Torino, defunto, mi raccontò di aver sentito a dire, non so da chi, che il Servo di Dio si portò da un signore in città, sotto la parrocchia di S. Agostino, perché aveva rifiutato altri confessori e che pressato da quel della famiglia a confessarsi perché molto ammalato, si indispettiva maggiormente. Arrivato Don Cafasso colle sue belle maniere e sante industrie lo indusse a confessarsi e comunicarsi.
La Marchesa Ceva di Nocito, vivente, mi scrisse che il Servo di Dio chiamato a confessare un'ammalata che non voleva sapere di sacramenti, questa rispose alle sue esortazioni con gettargli addosso il campanello. Allora il Servo di Dio si ritirò a pregare in un angolo della stanza, poscia con crocifisso in mano si presentò alla medesima dicendole: se essa vuol dannarsi, il Signore vuol salvarla. E tanto disse che la vinse e convertì. Non mi scrisse come essa abbia saputo questo fatto né chi sia stata quell'ammalata.
Il Canonico Bosso, già nominato, mi raccontò che alla vigilia della Comunione degli ammalati nell'Ospedale Cottolengo, non potendosi confessar tutti dai preti della Casa, vide che si chiamava dai Superiori anche Don Cafasso a confessare, il quale in breve tempo con comune soddisfazione ne confessava molti. Onde mi aggiunse che il Canonico Galletti, allora Prete della Piccola Casa, stupito di ciò, si propose di voler egli pure studiare la morale di Don Cafasso.
Nella relazione di Don Savio, che presentai, sta scritto che nella Piccola Casa quando vi erano dei peccatori ostinati, infermi, chiamavano Don Cafasso per confessarli, ed egli accorreva volentieri e riusciva sempre a convertirli. Lessi in una relazione scritta di pugno dal Servo di Dio, che conservo, e che egli scrisse per il Bollettino intitolato Sacro Cuore di Maria, che il Servo di Dio riuscì a convertire coll'intercessione della Madonna una giovane rotta ai vizi, e da questi ridotta in fin di vita e che era disperata e ricusava assolutamente i sacramenti.
MAESTRO DI PREDICAZIONE
Il Servo di Dio per molti anni fece scuola di predicazione agli allievi del Convitto, cioè dal 1840 almeno, fino alla sua morte, con qualche breve interruzione che dirò. Ciò provo 1° coll'attestazione del Can.co Barbiè Felice, che già ho presentato; 2° con alcune parole scrittemi da Don Balladore Antonio, vivente, Prevosto di Beinasco, Convittore negli anni 1843-44 e 1844-45; 3° da ciò che mi disse Monsignor Bertagna.
Il Can.co Barbiè nella detta relazione scrive dell'anno 1840 che il Servo di Dio quasi ogni quindici giorni, abbreviando di qualche minuto la sua conferenza privata, dettava una traccia su qualche argomento pratico e più specialmente su gli evangelii, massime di S. Giovanni che diceva il Checco del Signore ed il più sublime. Questi lavori si consegnavano in proprie mani a Don Cafasso, il quale li leggeva in privato, li annotava in margine e li restituiva a chi ne era l'autore. Era però solito dire: nel comporre siano chiari e discendano alla pratica, usando sempre che si può esempii, perché questi restando a mente degli uditori loro fanno ricordare le massime udite nelle prediche.
Don Balladore mi scrisse che il Servo di Dio, nel tempo che egli fu convittore, faceva scrivere prediche due volte al mese, le quali poi restituiva.
Mons. Bertagna mi disse, che nell'anno 1850-51 dettava Don Cafasso le tracce di predicazione e presiedeva alla lettura dei lavori; che fatta leggere una parte dell'assunto e fatte alcune osservazioni, era solito, sotto forma di dare una norma, di stendere tutta la parte e così successivamente i vari punti. Il medesimo mi aggiunse che dal 1851-52 sino a gran parte del 1855 Don Cafasso affidò quest'ultimo all'Avvocato Don Destefanis, ma che il pensiero di Don Cafasso era la base sopra cui questi lavorava. Venuto a morte l'Avvocato Destefanis, il lavoro fu ripreso da Don Cafasso, il quale in seguito lo affidò a Mons. Bertagna stesso per due anni, non ricorda più quali, ed in questi due anni Mons. Bertagna pigliava a voce la traccia dal Servo di Dio e, messa in iscritto l'idea come sapeva, la presentava di nuovo a Don Cafasso per l'ultima mano. Mons. Bertagna conchiuse, che dopo due anni la cosa ritornò a Don Cafasso. Mi aggiunse che gli alunni dovevano presentare il loro scritto al prefetto, il quale doveva leggerli tutti e farvi quelle annotazioni che avesse stimato; poi di regola il giorno fissato chiamava due o più spesso tre convittori a leggere, estraendoli a sorte. Mons. Bertagna mi disse questo perché vi fu presente come alunno e come superiore del Convitto in quasi tutti gli anni sopraccennati dal 1850 al 1860.
Conservo presso di me cinquantacinque traccie manoscritte del Servo di Dio, dettate dal 1847 al 1858; per la più parte riguardano i Santi Vangeli. Le regole che il Servo di Dio dava ai Convittori per la predicazione si trovano nell'ammirabile istruzione fatta per gli esercizi spirituali pei sacerdoti, di cui io tengo l'originale, la quale, cosa singolare! contiene gli stessi punti e lo stesso ordine che si ammirano nell'Istruzione data dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari pei predicatori di questi ultimi anni, eccettuato un solo punto, che riguarda il far polemiche o conferenze inopportune, che il Servo di Dio non tratta per iscritto, ma che i suoi allievi l'udirono svolgere a voce, come mi attestarono il Canonico Colombero ed altri che non ho presenti.
INDOLE DI DON CAFASSO
Quanto all'indole del Servo di Dio ho le seguenti cose a deporre. Già ho deposto sopra, che Don Allamano conobbe il Servo di Dio come d'indole molto vivace, che però sapeva ben moderare. Don Monsello, già nominato, mi attestò che come compagno di Seminario non vide mai il Servo di Dio maliconico, sebbene fosse un po' sofferente, che non lo vide mai adirarsi né dimostrare scoraggiamento od angustia di spirito; che teneva sempre gli occhi tranquilli e lo sguardo né troppo alto né troppo basso.
Don Perotti, Prevosto attuale di Riva di Chieri, che fu convittore nei tre anni 1854-55, 1855-56, 1856-57, mi scrisse: io credo che Don Cafasso avesse sortito da natura un naturale molto sensibile e pronto, eppure il modo dignitoso ed insieme piacevole e caricatevole con cui trattava i Convittori, la pazienza con cui si diffondeva a spiegare le questioni più delicate affinché tutti si facessero idee ben chiare, il rispondere senza lasciar trapelare un po' d'impazienza ad obbiezioni già lungamente sciolte, ed egli non risparmiare le parole, anzi metterne fuori un mare, ricorrere a vari casi per sempre meglio spiegar le questioni e, non bastando ancora, continuare inalterabile senza un po' d'acrimonia o di mordente naturale, ma con tutta dolcezza rispondere e ripetere le cose già dette e ridette senza lasciar nemmeno intravedere in sé la pena che si destava in tutti che l'ascoltavano [il periodo resta sospeso]. Questa virtù di carità e dolcezza instancabile in Don Cafasso, secondo me, sa di eroismo e non si acquista che con lungo esercizio di far violenza a se stesso. A che se si aggiunge la longanime assistenza al confessionale a tutti nota e poi incontrarlo qualche volta ad ora tarda a scendere le scale del Convitto, stanco, spossato di forze, fermarsi talora per prendere lena ed ascendere e tuttavia sempre di buon umore, con aria ridente, sempre eguale a se stesso trattare tutti colla solita sua dolcezza, allora si è persuasi che si tratta di una virtù e santità non comune. Onde tutti, anche quelli che allora sapevano di liberalismo, erano bene impressionati dal Convitto ed affezionati a Don Cafasso.
Di questo dominio che dimostrava sopra se stesso il Servo di Dio, parla Don Bosco nella biografia di lui; e la Marchesa Maria Fassati, vivente, la quale mi scrisse che ammirava nel Servo di Dio la sua imperturbabilità e soavità di modi nelle lunghe e noiose udienze, che dava ad ogni sorta di persone, trattando egualmente i ricchi ed i poveri, ed ascoltando collo stesso interessamento e bontà anche quelle persone, che a lui sovente si portavano per cose di poco rilievo, da rendersi noiose.
VII – CONTINUA L'ELENCO
Don Bosio Antonio, defunto, di cui ho già presentato la relazione, dice in questa, che la persona di Don Cafasso presentava un misto di serio e di sereno nel medesimo tempo; la serietà lo faceva rispettare; la serenità, effetto di sua virtù, specialmente della sua dolcezza, ispirava confidenza. Sempre eguale, e nessuno poteva accorgersi quando fosse contento o crucciato. Don Prato, già citato, defunto, nella presentata relazione scrive: sulla sua fisonomia, nel suo sguardo di luce speciale, direi, ispirato, traspariva alcun che di straordinario, che ispirava il massimo rispetto colla confidenza più illimitata. Era tutto a tutti senza dimostrare mai nausea o stanchezza anche nei suoi piccoli incomodi. Sempre d'umore eguale con un fare ilare ed amichevole anche in difficili circostanze, non si lasciava vincere da soverchia tristezza, ma tutto componeva in bel modo a gloria di Dio e bene delle anime.

Don Ribotta Nicolao, vivente, che fu convittore negli anni 1846-47 e 1847-48, mi scrisse che la schiettezza della verità e della giustizia, l'aria gioviale, buona, semplice, amica, rivelavano in lui il possesso della grazia, che pareva dell'innocenza battesimale, e lo rendevano caro a quanti lo conoscevano.
Certa Falchero Angela, d'anni 91, vivente, vedova di Giuseppe Falchero, affittavolo della cascina Rombelli, già di proprietà di Don Cafasso per eredità del Guala, mi disse che vide il Servo di Dio essere veramente sincero, ciò che aveva in bocca aveva in cuore, e ciò che aveva in cuore aveva in bocca: che amava molto la nostra bonarietà e sorrideva al racconto minuto ed alla buona delle nostre cose di famiglia. Don Baravalle, sopranominato, di cui ho presentato la attestazione, in essa scrive: l'esterno di Don Cafasso era sempre composto e grave e dimostrava apertamente il suo interno raccoglimento e si può con molta certezza affermare che il suo spirito era continuamente unito con Dio.
RITRATTO DI DON CAFASSO
Don Baravalle, sopranominato, di cui ho presentato la attestazione, in essa scrive: l'esterno di Don Cafasso era sempre composto e grave e dimostrava apertamente il suo interno raccoglimento, e si può con molta certezza affermare che il suo spirito era continuamente unito con Dio.
Sentii da Don Allamano, sopranominato, Don Traversa, Curato di S. Massimo, vivente Monsignor Bertagna, Can.co Roetti, Sig. Bargetto a dirmi che il Servo di Dio era di statura meno che mediocre, di complessione mingherlina, che aveva la spalla destra alquanto sollevata con relativa depressione della sinistra, lo stomaco alquanto sollevato, magro e pallido in volto, i capelli copiosi di color castagno scuro, naso un po' aquilino, fronte ordinaria, occhi neri e vivacissimi da non potersi resistere al loro sguardo, bocca ordinaria e mento ordinario, orecchie piccole, mani piccole e scarne, capelli sempre composti ma non coltivati.
DON CAFASSO PREDICATORE
Il Servo di Dio predicò in Castelnuovo d'Asti essendo ancor Diacono, per la prima messa del compagno Don Alla-mano già citato, come questi mi disse. Certo Rossatto Francesco, Michelotto Carlo di Cafasse presso Lanzo, credo viventi, mi dissero che nel 1842 il Servo di Dio andò a predicare la Missione di nove giorni con un certo Don Geni-nani, defunto, nel loro paese di Cafasse; che videro il Servo di Dio essere stato tenuto da tutti come un santo e che ricordano ancora l'effetto straordinario prodotto nel paese dalle di lui prediche, massime da quelle dell'inferno e del paradiso: quella li atterrì molto, questa molto li consolò. Detto Rossatto mi aggiunse d'aver visto che essendovi gravi disordini fra varie famiglie, la vigilia della comunione generale il Servo di Dio indusse tutte le famiglie a domandarsi vicendevolmente perdono delle offese e dei cattivi esempi dati; il che fu fatto con pianto generale e con commozione da non potersi esprimere.
Nello stesso anno 1842, o l'anno dopo, Don Ropolo, defunto, già nominato, e Don Savio, vivente, già nominato pure, mi dissero di sapere da persone del paese, delle quali non mi dissero i nomi, che il Servo di Dio andò a predicare la Missione di due settimane in Castelnuovo d'Asti col Teologo Borel, defunto, aggiungendomi che la Missione produsse grandi frutti e innumerevole concorso ai confessionali; dal che, mi disse Don Savio, crebbe ognor più nel paese il buon concetto che si aveva già di Don Cafasso.
Seppi da Suor Eufrosina della Carità (delle suore Bigie), vivente, da cinquant'anni addetta all'Ergastolo delle donne in Torino, che vide il Servo di Dio venire quivi a dettare gli esercizi spirituali alle donne ivi rinchiuse e fare le istruzioni in dialetto; ciò nell'anno del Giubileo concesso dal Papa, che essa crede sia il 1846; e che lo vide pure altra volta a dettarvi i santi esercizi nel 1854. Mi aggiunse che il Servo di Dio vi operò molto bene e convertì varie di quelle persone perdute, le quali si posero sulla buona via e vi durarono ed anzi alcune abbracciarono lo stato religioso; non mi disse in quale Istituto.
Che abbia predicato a donne carcerate o simili, lo rilevo da quattro prediche, che conservo manoscritte del Servo di Dio, nelle quali accenna a persone di tal genere, perché loro augura che siano presto rimesse in libertà.
La Baronessa Bianco, vivente, mi attestò di aver assistito nel 1860, dietro esortazione del suo confessore, Canonico Giordano, defunto, agli esercizi spirituali dettati da Don Cafasso nell'Istituto del Soccorso in Torino, Istituto femminile di educazione. Mi aggiunse che ne provò grande soddisfazione e che ricorda tuttora la consolazione provata per la predica sulla morte, per cui confessatasi dal Servo di Dio, ella, che molto temeva il morire, ebbe dal Servo di Dio assicurazione che in quel punto estremo i suoi timori sarebbero spariti. Di che essa si tiene sicura sulla parola del Servo di Dio.
Suor Serafina, Superiora del Monastero delle Adoratrici del SS. Sacramento, volgarmente dette Sacramentine, mi disse di sapere da Suor Veronica dello stesso Istituto, nel secolo Solaro della Margherita, ambedue viventi, che il Servo di Dio predicò gli esercizi a parecchie suore unite in preparazione alla vestizione o professione delle medesime, e che infine a detta suora lasciò per iscritto una memoria di pensieri e proponimenti spirituali, memoria che io conservo, datami dalla Superiora predetta.
Da una predica manoscritta sulla professione religiosa, che io conservo, del Servo di Dio, mi risulta che Don Cafasso predicò in chiesa pubblica in occasione della vestizione di qualche suora.
Dalla sopranominata Falchero Angela seppi che essa udì dal Servo di Dio essere egli andato a predicare al Cottolengo; e ciò le disse perché essa aveva smarrite due camicie, nel bucato, che il Servo di Dio disse rincrescergli la perdita, perché non sue ma del Cottolengo, che gliele aveva imprestate in occasione che ivi aveva predicato.
Anche Don Bosco parla nella citata biografia della predicazione che il Servo di Dio fece nei suoi primi anni di Superiore del Convitto, cioè dopo il 1837.
GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Don Cafasso si applicò particolarmente nel dettare gli esercizi spirituali al Clero che, come scrive Don Bosco nella citata biografia, pareva la porzione dell'umana società in modo speciale a lui affidata.
A questo fine fin dal 1835, essendo tuttora convittore, il Servo di Dio, prendeva note delle istruzioni e delle meditazioni, che sentiva negli esercizi al santuario di S. Ignazio, dei quali appunti conservo gli originali stessi, scritti dal Servo di Dio per dieci anni. Circa questo tempo compose pure quattro quaderni di testi tolti dalla Sacra Scrittura e dai Santi Padri in ordine alla predicazione, come appare dalla stessa forma di scrittura. Dopo aver scritto nel 1840 la Missione pel popolo, come appare da alcune espressioni che lessi nei manoscritti di essa, che conservo, compose una prima serie di meditazioni per gli ecclesiastici, dal 20 ottobre 1842 all'8 aprile 1844, da farsi per otto giorni con tre prediche al giorno, come per alcuni anni si usò fare al santuario di S. Ignazio. Più tardi compose altra serie o meglo due altre serie di meditazioni agli ecclesiastici, che sono piuttosto una correzione e bella copia della prima serie. Più tardi ancora scrisse le istruzioni per gli esercizi spirituali ai sacerdoti. Tutti questi manoscritti io conservo, eccetto alcune prediche, che non rinvenni, e da essi ho veduto con quanta cura si preparò al ministero della predicazione.
Nella prima predica delle meditazioni, cioè sul fine dell'uomo, si leggono le seguenti parole: « per comando che mi fu fatto incomincio questa predicazione ».
Don Giacomelli mi disse che Don Cafasso predicò per la prima volta la predicazione delle meditazioni in S. Ignazio nell'anno 1844, mi pare perché fu presente. Continuò tutti gli anni, o quasi tutti, a predicare colà le meditazioni fino all'anno della sua morte, ad eccezione di qualcuno degli ultimi anni, nei quali fece le istruzioni invece delle meditazioni. Ciò seppi dal Canonico Roetti, da Don Giacomelli e da vari altri, di cui non ricordo il nome. E quanto alle meditazioni risulta da questo fatto, che la camera propria a darsi al predicatore delle meditazioni, perché fu occupata tante volte da Don Cafasso, venne comunemente chiamata la camera di Don Cafasso.
VIII - PREDICATORE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
 Conservo nelle memorie del convitto due soli elenchi degli esercitandi sacerdoti, che sono quello del 1846 e del 1847, nei quali leggo quale predicatore delle meditazioni Don Cafasso. Questi elenchi sono scirtti da Don Strumia, defunto, economo del Santuario.
Conservo nelle memorie del convitto due soli elenchi degli esercitandi sacerdoti, che sono quello del 1846 e del 1847, nei quali leggo quale predicatore delle meditazioni Don Cafasso. Questi elenchi sono scirtti da Don Strumia, defunto, economo del Santuario.
Don Cerva, vivente, Prevosto di Casalgrasso, mi disse di aver udito Don Cafasso a predicare le istruzini al clero in S. Ignazio nel 1858.
Una sola lista pervenne nelle mie mani degli esercitandi secolari di S. Ignazio, che conservo, ed è del 1846, nella quale è notato che predicò il Servo di Dio le istruzioni. Da vari esercitandi secolari, dei quali non ricordo i nomi, udii a dire che essi intervennero agli esercizi in diversi anni, dettati dal Servo di Dio.
Un sacerdote del Santuario di Graglia (Biella), del quale non so il nome, vivente, mi disse che il Servo di Dio predicò in quel Santuario gli esercizi spirituali al Clero e mi aggiunse che fra i sacerdoti Biellesi era tuttora viva la memoria di quella fruttuosa predicazione, secondo che sentì da quei sacerdoti che intervennero.
Monsignor Ighina, attuale vicario Capitolare di Mondovì, e Don Aragno Carlo, Priore di Magliano Alpi (Mondovì), mi scrissero che il servo di Dio dettò gli esercizi spirituali al Clero nel Seminario di Mondovì. Questi aggiunse le seguenti parole: Non solo lo udii come apostolico predicatore, ma profittai del suo sacro ministero nel sacramento della Penitenza; nell'uno e nell'altro ufficio con tutti i molti sacerdoti partecipanti ammirai la soda e pratica dottrina da lui esposta e la sua santità che traspariva dalla sua illuminata, pronta, vivace ed incisiva parola, che penetrava fin nell'intimo del nostro cuore e lo muoveva e quasi trascinava a Dio. Come confessore poi egli mi pareva ispirato ed impareggiabile, amoroso padre, dotto maestro, savio consigliere, tenerissimo amico, versava su tutte le piaghe l'olio del Samaritano et sanabat omnes. Unanimemente tutti entusiasmati esclamavamo: Don Cafasso ha con lui lo spirito di Gesù Cristo.
In una lettera del Servo di Dio scritta a Don Burdino nel 1855, che conservo, lessi che ritornava allora dal dettare gli esercizi spirituali al Clero di Cussanio (Fossano).
Don Sciolli Rocco, ex parroco di Salmour, vivente, mi disse che udì don Cafasso a predicare gli esercizi spirituali di dieci giorni in Cussanio nel 1855, ed udì il Vicario Capitolare.
Mons. Abrate, nell'annunziare i predicatori, a dire che aveva invitato due sacerdoti celebri, uno per santità, zelo e dottrina, alludendo a Don Cafasso, l'altro per soda scienza e per altre virtù e doti, alludendo al Padre Stub Barnabita.
Don Giacomelli mi disse che il Servo di Dio predicò pure esercizi al Clero in Susa, e ciò seppe perché lo incontrò in Avigliana mentre da Susa faceva ritorno a Torino.
Mons. Bertagna, Don Buzzani, viventi, Don Ropolo, defunto, mi dissero che il Servo di Dio predicò gli esercizi al Clero nel Santuario della Madonna dei Fiori in Bra negli ultimi anni di sua vita.
Il Canonico Giuseppe Cerutti, arcidiacono della Cattedrale d'Asti, defunto, mi scrisse queste parole: per tanti anni frequentai gli esercizi spirituali nel Santuario di S. Ignazio e quasi sempre sentii Don Cafasso a predicare con mia grande soddisfazione e meraviglia.
Mons. Bertagna mi disse che il Professore Can. Marengo, ritornato dagli esercizi spirituali dettati dal Servo di Dio a S. Ignazio nei primi anni di sua predicazione, gli disse che era così penetrato dall'efficacia della parola di Don Cafasso, che ne discorreva cogli amici con vero trasporto, e andava dicendo: quest'uomo dominerà tutto il Clero.
Il Canonico Giordano, defunto, nella predica d'introduzione agli esercizi spirituali al Clero, stampati nella tipografia degli Artigianelli nel 1878, pagina 24, dopo ricordato gli autori di cui si servirebbe nella predicazione, il Beato Leonardo, Sant'Alfonso, il Bellecio, scrive: e soprattutto quell'uomo, che ci predicava pochi anni fa, Don Cafasso, quell'uomo che venero come un santo e tenterò di seguire come maestro. E nella predica sulla morte, ricordato il Servo di Dio, soggiunge: lascia al tuo povero figliolo, che almeno una volta pronunciai il tuo nome da quest'altare ove tu spargesti tanti sudori, e tanta pace versasti nei poveri nostri cuori.
Mi sta presente la sua meditazione sulla morte del giusto: egli ne parlava con un accento di convinzione e sapeva ragionarne con modo affatto suo; mí ricordo che tutti noi ervamo silenziosi a divorare le lacrime che ci cadevano, ed egli a farci coraggio (pagina 147). Il Canonico Berteu, vivente, mi disse che incontrati una volta per Torino a Canonico Ortalda ed il Canonico Giordano, defunti, avendo l'uno dato all'altro la notizia che predicherebbe in quell'anno gli esercizi a S. Ignazio Don Cafasso, li udì dire: dunque allora andiamo a farli. Noto qui che a S. Ignazio si davano due mute di esercizi al Clero per alcuni anni, ed i sacerdoti erano ansiosi di sapere in quale predicasse il Servo di Dio.
Il Canonico Allaria, attuale Vicario generale della Diocesi di Alba, mi scrisse le seguenti parole: Le riminescenze di quella predicazione (di Don Cafasso) sono tuttora così fresche, soavi, intime che non di rado ci avviene di incontrarci con alcuni dei suoi antichi allievi, i quali ne riportano a memoria con vivo entusiasmo e salutare compunzione i punti più salienti e piangono di aver così presto perduto un maestro di sì preclari ed incomparabili meriti. Don Carena Biagio, vivente, mi scrisse: so che dettò moltissime volte ed in varie Diocesi gli esercizi spirituali, specialmente ai sacerdoti, e so di scienza propria ed anche per relazione altrui che il suo dire era così facile, ordinato, persuasivo e pieno d'unzione, che era ascoltato volentier da tutti, parroci, canonici e vescovi.
Si vedeva che la sua predicazione era frutto della preghiera e dello studio, cose che raccomandava tanto ai sacerdoti nel predicare come nel confessare: apriva tanto il cuore alla confidenza. Il Padre Stub, Barnabita, defunto, nel 1860 dettando gli esercizi a S. Ignazio, parlando della scienza e dello zelo sacerdotale, fece tale elogio di Don Cafasso da commuovere tutti. Ciò seppi da Don Ropolo che fu presente, e mi aggiunse che in fine degli esercizi si celebrò un solenne funerale in suffragio di lui morto poco prima.
APOSTOLO DEI CARCERATI
Ho già detto sopra che Don Cafasso come convittore andava a fare il catechismo ai carcerati; cosa che pure mi attestarono il Canonico Borsarelli, defunto, assiduo confessore anch'egli nelle carceri, ed il Sig. Bargetto, già nominato. Divenuto prefetto e ripetitore in Convitto, si dedicò con tutte le forze a lavorare nelle carceri, istruendo e confessando. Don Sassi Giuseppe, defunto, Convittore nel 1839-'40 e 1840-'41, mi scrisse che i carcerati erano i prediletti del Servo di Dio, e che traeva profitto da tutte le occasioni per soddisfare all'ardente desiderio di beneficarli anche materialmente.
Il medesimo mi raccontò che una sera dopo cena, essendo noi Convittori attorno al Rettore, Teologo Guala, a Don Cafasso e a Don Begliati, il Servo di Dio, preparatosi il terreno, fece cadere il discorso sui poveri carcerati, e diceva: Oggi li ho visitati tutti e non c'è male, ma ne trovai uno con un appetito formidabile poiché l'aria è fresca eccellentemente. Trovavasi un altro con un paio di calzoni sottili, che batteva precipitosamente la solfa coi denti. Tutti ridevano, ma Don Begliati economo, serio serio disse: mano alla borsa, signor Rettore! Don Cafasso sapeva rispondere soavemente e con grazia da ridestare l'universale ilarità. Intanto il Teologo Guala conchiudeva dicendo a Don Cafasso: fate pure, fate pure. Così Don Cafasso otteneva maggiori soccorsi pei carcerati.
Nei registri della Compagnia della Misericordia, consultati dal Teologo Gaia, che mi riferì quanto dico, si legge che il Servo di Dio vi si inscrisse come confratello nel 1842. Il signor Brognino Giuseppe, defunto, mi disse le cose seguenti: Don Cafasso fu il primo a' miei ricordi che si occupasse in modo speciale delle prigioni. Egli apparteneva alla Compagnia della Misericordia, la quale era costituita da trecento Confratelli, di cui otto soltanto erano scelti annualmente per visitare le carceri, e sovvenire ai prigionieri, nei loro bisogni sì spirituali che temporali. Io ebbi la fortuna di essere nel numero di costoro, essendo io pure confratello di questo pio sodalizio, perciò ho potuto conoscere da vicino la carità di Don Cafasso verso quei poveri disgraziati. Egli era solito a dirci che i prigionieri bisognava trattarli il meglio possibile e non mai riferire contro di loro lagnanze all'Avvocato Generale per farli castigare come avevamo diritto, poiché, soggiungeva egli, sono già troppo maltrattati dai custodi. Ricordo tuttora che il primo avvertimento datomi da Don Cafasso quando venni ammesso a tale ufficio fu questo, di pensare che i prigionieri fossero tutti galantuomini e di trattarli come tali e di non mai offendermi per quanto venissi da loro ingiuriato. Le prigioni in Torino erano quattro: le Torri, Via San Domenico, il Correctionnel ed il Senato. Don Cafasso quantunque potesse aiutare i prigionieri coi denari della Misericordia, tuttavia li soccorreva sempre del proprio.
IX - PANE E VINO PER I CARCERATI
Don Cafasso faceva distribuire sovente ai carcerati pane fresco per sostituirlo al duro delle prigioni. Aveva poi cure specialissime per i prigionieri ammalati, a loro assegnava la minestra ed ordinava ai custodi di contentarli in ciò che si poteva, soddisfacendo poi il tutto di propria borsa. Alle volte consegnava ai prigionieri somme di denaro non solo per loro ma anche per le rispettive famiglie. Le sue minute offerte non erano mai inferiori ai 20 centesimi; tabacco poi ne dava a profusione.
Non fece mai castigare alcuno, che anzi, quando veniva da loro oltraggiato, cercava sempre di scusarli e continuava a soccorrerli. Quelli che uscivano di prigione venivano anche dopo da lui aiutati ed impiegati.

Egli conduceva pure seco per fare il catechismo altri sacerdoti, consegnando loro somme e tabacco da distribuire. È inutile dire che uscendo dalle carceri dovevano spogliarsi completamente. Ho udito dire che una sera fu chiuso in prigione e lasciato colà tutta la notte, e ciò non a caso, ma a bella posta, per un po' di dispetto dell'Avvocato Generale. Tutto questo mi disse il predetto Brogino, il quale fu confermato per tanti anni uno degli otto visitatori. Non mi disse poi se il Servo di Dio andasse come uno degli otto, oppure se, come sacerdote della Misericordia, avesse libero adito alle carceri. Il sig. Tamietti Giovanni, vivente, che per sei anni fu prigioniero nelle carceri del Senato ed ora ottimo cristiano, mi disse che rapito dalla tanta carità di Don Cafasso mentre era ateo e incredulo, si fece credente e decise di abbandonarsi totalmente nelle braccia del Servo di Dio per rimediare un tantino ai tanti scandali dati, e fatta famigliarità col Servo di Dio, gli divenne suo confidente e financo suo consigliere in cose minime, come nel consegnare il tabacco che regalava perchè lo distribuisse imparzialmente, stanteché il Tamietti non usava tabacco; come pure nel condurre al Servo di Dio per confessarsi i prigionieri. Don Cafasso lo avvertiva della sua venuta, ed il Tamietti gli accaparrava i penitenti ed egli si confessava sempre l'ultimo per non dar sospetto.
Detto Tamietti mi disse ancora le seguenti cose. Don Cafasso visitava tutte le carceri di Torino, tanto degli uomini, quanto delle donne, ma particolare-mente si occupava delle carceri del Senato, dove erano i carcerati in numero di circa cinquecento. Don Cafasso nell'apparire in un « colloquio », (così si chiamava un gran camerone contenente una cinquantina di prigionieri) lo si vedeva ilare, in gioia, faceto, e diceva: qui mi trovo nel mio elemento: qui non ho più alcun fastidio, una sola cosa desidererei, cioè di avere una camera anche per me per starci dì e notte coi miei amici. egli era sinceramente amato da tutti, e gli stessi più perversi ne parlavano con entusiasmo. Quando entrava nel cortile, dove da tutti i piani poteva essere veduto, era come una scintilla elettrica che accendeva una baraonda di gioia, una giovialità ed una, dirò così, ondata spingeva tutti a lui acclamando: Don Cafasso!
DON CAFASSO!
Don Cafasso mandava pure i suoi con vittori per insegnare il catechismo, assegnando a ciascuno un « colloquio ». Don Cafasso faceva distribuire pane a tutti i carcerati, due « michette » a testa, giungeva sempre all'improvviso dopo mezzogiorno, e presentantosi ad un « colloquio », domandava: quanti siete? Siamo quarantacinque. — Bene, soggiungeva, novanta « michette ». Oltre questi soccorsi eravi pure la parte degli sbirri, che era del doppio degli altri. Una volta, nel forte dell'estate, che eravi un gran languore, dietro il mio consiglio, in luogo di pane, distribuì un quartino di vino a testa. — Fin qui il Tamietti, nelle carceri chiamato per soprannome il ravveduto. A proposito del vino, ricordo che Rossotto Antonio, massaro delle Cascine di Rivalba, di proprietà del Servo di Dio, mi disse che per l'ordine di Don Cafasso, qualche volta condusse alle carceri del Correctionnel del vino dalle cascine suddette.
Il Canonico Borsarelli, defunto, Canonico della Metropolitana di Torino, che frequentava pure le carceri, mi disse che l'entrare del Servo di Dio nelle carceri era una festa.
Don Giolitti Giuseppe, attuale pievano vicario foraneo di S. Catterina di Vigone, che fu convittore nell'anno 1856-'57, mi scrisse che in quell'anno i carcerati che egli andava come convittore a catechizzare, parlavano con entusiasmo di ammirazione e di affetto del Servo di Dio onde ne restava altamente meravigliato e non dimenticò mai tali lodi.
« SONO UN MEZZO UOMO »
Don Bosco, testimonio pure di presenza, perché frequentò pur egli le carceri dietro impulso del Servo di Dio, come mi disse il Teologo Borel, nella Biografia già citata, parla lungamente del bene operato da Don Cafasso nelle carceri; e di questo parlano pure quasi tutte le relazioni, sia già presentate, sia che presenterò.
Lo studio che faceva il Servo di Dio per ridurre i prigionieri sulla buona via appare dai fatti seguenti.
i° Don Mussino, vivente, cappellano di Val della Torre, mi scrisse che nel 1847 essendo in carcere una donna, il Servo di Dio si informò da un sacerdote del paese della medesima sulle particolarità della disgraziata, ed andato poi a trovarla nelle carceri, la chiamò col soprannome usato in quel paese; e così si fece strada nel suo cuore che convertì prima che fosse trasportata a Pallanza a scontare la pena a cui era stata condannata.
Don Mussino non mi disse come abbia saputo questo fatto.
2° Don Ribotta, cappellano in Cavour, pure vivente, mi scrisse che mentre il servo di Dio un giorno si tratteneva dolcemente a conversare con molti detenuti, uno solo, burbero, se ne stava in un agolo vomitando bestemmie. Il Servo di Dio, lasciando tutti gli altri, si avvicinò a colui e, dicendolo uomo di molto spirito e degno di ragionare a tu per tu di cose superiori alla capacità degli altri, lo ragionò e convertì. Non mi scrisse il Ribotta come ciò abbia saputo. Don Grassino, attuale parroco di Scalenghe, disse al Teologo Gaia, che me lo riferì, che essendo convittore per tre anni (dal 1847 al 1850) venne mandato dal Servo di Dio nelle prigioni, ed una volta si portò via pidocchi, sicché giunto a casa dovette cambiarsi completamente. Affrettatosi al primo incontro a ciò raccontare al Servo di Dio, questi sorridendo gli rispose: li tenga in conto, sono bocconi del prete. Il Canonico Don Motta Giacomo, attuale prevosto di Trana, mi scrisse che una volta avendo il Servo di Dio invitato un carcerato a confessarsi, questi presolo per la gola gli disse di essere capace di strangolarlo. Al che il Servo di Dio rispose, che certamente poteva ciò fare su di lui, che era solo un mezzo uomo, ma che tuttavia egli coll'aiuto di Dio, che era più forte, sperava di farlo arrendere agli inviti della grazia; e finì per ridurlo a conversione. Non mi scrisse come abbia saputo questo fatto.
Monsignor Galletti, nella relazione presentata, dice che don Cafasso a S. Ignazio gli raccontò le grandi consolazioni provate fra i detenuti nelle carceri Senatorie e Correzionali.
Don Giolitti, sopraddetto, scrissemi che il Servo di Dio godeva talmente la stima e la confidenza dei carcerati, che gli confidavano anche i loro segreti: come quando, d'accordo, i carcerati, d'un « colloquio », a fabbricarsi grimaldelli coi ferri da calze, coi quali lavoravano, erano già riusciti ad aprirsi tutte le porte meno l'ultima. Quando venuto Don Cafasso a vederli, gli dissero che un'altra volta non li avrebbe più trovati, mostrandogli i grimaldelli. Invece quanto ritornò, li ritrovò tutti in carcere, eccetto uno, e temendo che pensassero che egli avesse tradito la loro confidenza, li interrogò del come, e seppe che uno di essi, perché trasportato altrove, aveva denunziata la trama. Don Giolitti mi scrisse che cio' seppe dallo stesso Don Cafasso.
Don Allamano, più volte citato, mi raccontò, senza dirmi come lo seppe, che una notte d'inverno Don Cafasso venne chiamato per andare a confessare un soldato ammalato fuori cinta di Torino. Ritornando in vettura, fu fermato da alcuni assassini, i quali si affacciarono coi lumi alla carrozza. Chi accompagnava il Servo di Dio voleva reagire e sparare l'arma da fuoco che aveva, ma don Cafasso gli trattenne il braccio dicendo: no, di me non importa, ma di essi, poverini, che ne sarà? Quelli, riconosciuta la voce di Don Cafasso, dissero: Vada avanti tranquillo, Don Cafasso, nessuno gli recherà molestia, e così fu libero.
Cafasso Pietro, fratello del Servo di Dio, mi raccontò che, conducendo egli il Servo di Dio da Castelnuovo a Villa-nova d'Asti in carrozza, giunti presso i boschi di Riva di Chieri, furono affrontati da due malandrini, che chiesero loro i danari. Don Cafasso, che era avvolto nel mantello, si scoperse e si fece riconoscere da uno di essi, di cui aveva fatto conoscenza nelle carceri; il quale riconosciuto il Servo di Dio, si gettò in ginocchio e domandò perdono_ Don Cafasso lo ammonì paternamente e gli diede l'elemosina. Questo malandrino mi raccontò pure egli stesso il fatto, ed io noto che si convertì e perseverò nel bene, come io lo vidi in paese.
X - PER I CONDANNATI A MORTE
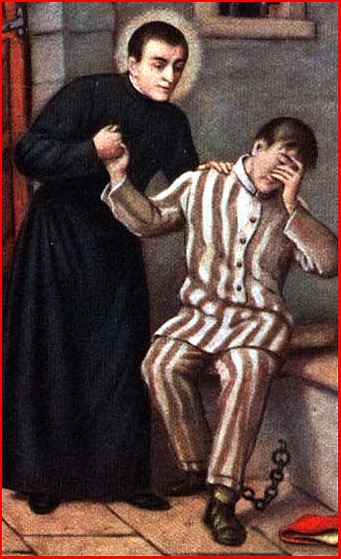 Nel testamento del Servo di Dio, al n. 10, lessi: Lascio la limosina di lire una per caduno dei prigionieri che si troveranno nelle carceri di questa città, dette cioè del Senato, Cittadella, Correzionale, delle Forzate, e delle Torri. La distribuzione sarà fatta dentro il mese dopo il mio decesso dal mio erede o da persona dal medesimo designata. Il Tamietti, sopracitato, mi disse ancora che trovandosi in carcere con lui due protestanti, Don Cafasso li convertì, ed usciti di carcere i medesimi, uno lo fece entrare al Catecumenato di Torino, l'altro lo raccomandò al Catecumenato di Pinerolo.
Nel testamento del Servo di Dio, al n. 10, lessi: Lascio la limosina di lire una per caduno dei prigionieri che si troveranno nelle carceri di questa città, dette cioè del Senato, Cittadella, Correzionale, delle Forzate, e delle Torri. La distribuzione sarà fatta dentro il mese dopo il mio decesso dal mio erede o da persona dal medesimo designata. Il Tamietti, sopracitato, mi disse ancora che trovandosi in carcere con lui due protestanti, Don Cafasso li convertì, ed usciti di carcere i medesimi, uno lo fece entrare al Catecumenato di Torino, l'altro lo raccomandò al Catecumenato di Pinerolo.
Don Ellena Secondo, Prevosto di Bussano, vivente, ed il Can. Gaude, defunto, Prevosto di Poirino, mi scrissero la stessa cosa, che cioè la missione di Don Cafasso intorno ai condannati a morte ebbe principio da un giustiziato che morì impenitente. Il quale fatto, Don Ellena dice essere avvenuto in un paese del Canavesano, nel 1839, alla quale esecuzione il servo di Dio fu presente ed accompagnava i sacerdoti che assistettero l'infelice; e ciò dice d'aver sentito narrare da persone di quei paesi. Il Can. Gaude scrissemi di aver udito ciò dallo stesso Servo di Dio, che simile fatto era succeduto in Torino, essendo egli, il Servo di Dio, assente dalla città di Torino. Tutti e due poi concordano nel dire che, addolorato per tale fatto, il Servo di Dio andò a prostrarsi davanti al SS. Sacramento e consacrò tutto se stesso a Dio per l'assistenza dei condannati a morte, alla condizione che il Signore gli facesse la grazia che nessuno da lui assistito rifiutasse di convertirsi. Don Ellena non mi scrisse come abbia saputo questo.
Il Can. Gaude invece mi scrisse di aver udito questo dallo stesso Don Cafasso. L'evento provò che il Servo di Dio fu esaudito nella sua preghiera, poiché Don Bosco scrive nella già citata biografia (pag. 84) che niuno poté mai resistere alla presenza, alle parole, alla carità di Don Cafasso. Il medesimo Don Bosco aggiunge che il Servo di Dio, si consolava in cuor suo ed, a maggior gloria di Dio, andava coi suoi amici dicendo che dei condannati, in questa capitale ed altrove da lui assistiti negli ultimi momenti, nemmeno uno fosse morto senza che avesse lasciate fondate speranze di eterna salvezza. Ciò mi fu confermato dal Can. Bosso e dal Teologo Gallo, che me lo scrissero, e dal sig. Brogino, che mi disse la cosa essere assolutamente certa; noto come il Brogino, defunto, fu per tanti anni, fino alla morte di Don Cafasso, uno dei cosiddetti compagnoni della forca, cioè un confratello dei destinati dalla Compagnia della Misericordia ad assistere i condannati all'estremo supplizio.
Quanti abbia assistito di condannati il Servo di Dio non saprei in modo certo. Nei registri della Compagnia della Misericordia, che consultai dal 1840 al 1860, sono notate cinquatadue esecuzioni capitali in Torino; fra cui non son comprese le esecuzioni fatte nei paesi delle provincie e neppure le fucilazioni militari. Don Garino, attuale Prevosto di Romano Canavese, mi scrisse che il Servo di Dio andò colà ad assistere due condannati per omicidio, Raggia Antonio e Vaio Antonio il 2 gennaio 1853, e mi soggiunse che essendo riuscite vane le cure dei sacerdoti mandati da Monsignor Moreno, Vescovo di Ivrea, fu invitato Don Cafasso, il quale li indusse a morire rassegnati e riconciliati con Dio coi sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, come dice aver letto nei registri della sua parrocchia. Soggiunge pure che vivono tuttora alcuni suoi parrocchiani, che ricordano l'andata colà del Servo di Dio e che, dalla bocca d'un sacerdote del paese, diverse volte udì narrare le sante industrie che il Servo di Dio usava e suggeriva di usare per indurre i due condannati a convertirsi, lasciando in tutti coloro che l'avvicinarono l'impressione di un santo.
Il Sig. Bargetto, già nominato, mi disse che una volta il Servo di Dio andò ad assistere un condannato a morte a Vercelli. — Mons. Appendini, defunto, Don Martino, defunto (nella relazione di quest'ultimo, che ho presentata), mi scrissero che il Servo di Dio assistette alla fucilazione del Generale Ramorino. — Don Ferraris Giuseppe, di cui presento la relazione, cappellano in Cumiana, defunto, mi scrisse alcune particolarità sull'assistenza di Don Cafasso alla fucilazione del Generale Ramorino. Di ciò parlano pure altre relazioni già presentate.
Falchero Angela, già nominata, mi disse che essa fu presente a cinque esecuzioni in Torino, fra cui a quella della banda Artusio, e mi disse di sempre aver visto sul carro accanto ai condannati Don Cafasso.
Don Camossetti, attuale Vicario Foraneo di Ciriè, mi disse di aver visto, essendo ragazzo, il Servo di Dio ad accompagnare sul carro dei condannati presso la Basilica Magistrale in Torino, e d'aver udito da uno dei presenti a dire: quel sacerdote gobbo là, sì che è un santo!
Bargetto sunnominato, Don Bosio, parroco di Levone, già nominato, Don Prato, parroco di S. Giovanni di Savigliano, e Don Savio, mi scrissero che Don Cafasso assistette alla esecuzione di certo Mottino, detto il Bersagliere, nativo di Candia Canavese, l'undici dicembre 1854.
UN INCARICO PER IL PARADISO
Don Bosco, nella citata biografia a pag. 84, scrive che Don Cafasso fu un vero eroe per guadagnare al cielo questi infelici e ne descrive le industrie per convertirli e disporli alla morte. — Il Can. Roetti, già nominato, Don Ellena Secondo, Prevosto di Busano, Don Rolando Domenico, vivente, Prevosto di Pessinetto, mi scrissero che il Servo di Dio usava cura speciale, per non solamente fare loro ricevere i santi Sacramenti, ma ancora per farli rassegnare ed accettare la morte in pena dei loro peccati e financo per fare la volontà di Dio e dargli gusto; il che secondo Sant'Alfonso è un atto di virtù il più perfetto: nullus actus perfectior est. Soggiungono i medesimi che il Servo di Dio era così persuaso di ciò, che talora ritornando fra i Convittori esclamava con giubilo: un'anima di più in Paradiso!
Don Bosco scrive pure nella citata biografia: era rarità di Don Cafasso di ispirare grande confidenza in chi pareva disperato; egli aveva il modo di cangiare la disperazione in viva speranza ed infiammato amor di Dio, sicché non di rado i pazienti montavano con gioia la scala fatale e ridendo accoglievano il colpo fatale; a segno che un carnefice ebbe ad esclamare: alla presenza di Don Cafasso la morte non è più morte, ma una gioia, un conforto, un piacere.
Tamietti, suddetto, così racconta, scrivendomi come testimone di veduta per tutto il fatto, eccettuata l'esecuzione fuori carcere: Un giorno Don Cafasso venne alle carceri e contro il suo solito, sebbene si sforzasse di essere ilare, si capiva che aveva nel cuore una pena, ed era che desiderava di confessare uno che egli già sapeva durante il processo che sarebbe certamente condannato a morte, ed ancor non lo conosceva. Ma ecco che io glielo presento uno dei primi a confessarsi. Dopo la confessione, lo vidi con un'aria così allegra e contenta che non poteva stare senza esclamare: oh quanta consolazione si gode a confessarsi! Qual anima santa egli è mai questo Don Cafasso!
Io non posso esprimere la pace e la gioia di che mi sento inondato.
Pochi giorni dopo ritornato Don Cafasso, costui si confessò di nuovo e, contento ancor più di prima, esclamò: oh quanto io era stupido a non confessarmi! Non istupisco più che il nostro amico qui (alludendo a me) che si confessa sia così allegro e tranquillo. Pochi giorni dopo è giudicato ed è condannato a morte. Don Cafasso va a trovarlo in Confortatorio, e lo trova tutto allegro, e si sente dire da lui stesso la notizia fatale. Dopo averlo confessato gli dice ancora: Sentite, io a venire ad assistere i condannati ci vengo per niente, ma se vi domando un piacere me lo negherete? - E qual piacere posso mai farvi io nel punto in cui mi trovo? - Il piacere è questo: appena sarete morto, voi andrete subito in Paradiso e tosto ... - Come, subito in Paradiso? nemmeno in Purgatorio? - Non ci andrete, ma di volo in Paradiso, e colà giunto andate subito a ringraziare la Madonna. - Come, la Madonna prima del Signore? - Sì, sì, prima del Signore. - Ma il Signore potrebbe offendersi. - No, non si offende. - Ebbene, se si offende, io gli dirò che fu Don Cafasso che me lo domandò. - Sì, e là che sarete vi inginocchierete ai suoi piedi, la ringrazierete e le direte che prepari un posto anche per me. Me lo fate questo piacere? - Ve lo prometto. Al mattino poi, ricevuta la Comunione da Don Cafasso, il condannato ringraziò me (Tamietti) e per memoria cambiò il rosario che aveva al collo col mio. Venuta l'ora, salì sul carro e dato uno sguardo alla gran turba che lo guardava, disse a Don Cafasso: Lo crede, che tra tanta gente che mi guarda, il più tranquillo son io? - E Don Cafasso disse poi che, tastatogli il polso, glielo trovò tranquillo, come mi disse dopo. Giunti alla forca e saliti due gradini si volta indietro dicendo a Don Cafasso: adesso vado a fare la sua commissione alla Madonna; vede che non mi dimentico. E qui finì. Il Conte Cibrario nella sua storia di Torino stampata nel 1846 (vol. II, lib. V, cap. I) secondo che io lessi, riferisce lo stesso fatto nelle principali sue particolarità, e dice in nota averlo udito dalla bocca stessa di Don Cafasso che assisteva detto giustiziando.
Il Canonico Roetti mi scrisse che la vigilia dell'esecuzione udì Don Cafasso a raccomandare ai Convittori, tra cui si trovava, i condannati a morte, perché pregassero per loro.
Il Canonico Gaude, già nominato, mi scrisse che Don Cafasso raccomandava alle preghiere dei Convittori e dei penitenti i condannati a morte, e che egli nel memento della S. Messa ne faceva speciale menzione. Non mi scrisse come seppe ciò.
Il Sig. Bargetto mi disse che dopo la mezzanotte precedente qualche esecuzione, Don Cafasso accompagnato da un domestico si portava alle carceri, e il Brogino sopra citato mi disse di essere andato a prenderlo al Convitto, come confratello della Misericordia ed averlo accompagnato alle carceri. Detto Brogino mi aggiunse che vide Don Cafasso a celebrare nel confortatorio, a comunicare il paziende prodigandogli le ultime consolazioni della fede, che dopo la S. Messa mentre il paziente veniva subito legato innanzi all'altare dal carnefice, che prima gli domandava perdono di dover fare questo suo ufficio, Don Cafasso cercava di distrarre il condannato con santi pensieri, in modo che questi fosse meno impressionato di ciò che si operava sulla sua persona, e così lo intratteneva alla sua partenza.
Il Brogino mi soggiunse di non aver mai visto il Servo di Dio a svenire nell'assistere i condannati a morte, come vide succedere ad altri sacerdoti: ma sempre forte sapeva anche infondere coraggio in altri sacerdoti e noi altri confratelli della misericordia. Ci diceva che non pensassimo a ciò che si operava, ma al delitto commesso o, piuttosto, al gaudio che i poveretti fra breve gusterebbero in Paradiso.
La Damigella Garneri Maria, defunta, mi disse di aver visto il Servo di Dio, che, terminato il supplizio, accompagnava i confratelli fino alla chiesa della Misericordia, e lì si fermava sino alla fine della Messa che si celebrava in tale occasione. Uscendo il Servo di Dio dalla chiesa, una turba di poveri lo aspettava, cui egli dava elemosina. Il Canonico Bianco Spirito, vivente, mi scrisse che seppe dal Canonico Negri di Carmagnola, vivente, che mentre il Negri predicava nel paese della Vezza d'Alba nel 1855, il Servo di Dio aveva scritto una lettera consolatoria ai parenti di un giustiziato oriundo di quel paese, assistito da lui; nella quale lettera il Servo di Dio assicurava i parenti che l'infelice aveva fatto una buona morte.
XI - OPERARE AL SANTUARIO DI SANT' IGNAZIO
 Il Servo di Dio fu pure rettore ed amministratore del santuario di Sant'Ignazio, secondo l'atto già inserito. In questa qualità, lessi nei registri del santuario (che conservo come rettore del santuario stesso) che a supplire alle spese occorrenti per il santuario (cioè per la chiesa, il fabbricato, e la strada da Lanzo) egli impiegò del suo lire ventimila duecento sessantacinque. Per altro diede il denaro ad imprestito senza interesse all'amministrazione del santuario, con approvazione dell'autorità ecclesiastica. Il Servo di Dio nel testamento condonò detta somma, mettendo la clausola che continuasse la destinazione del santuario per gli esercizi spirituali e le solite funzioni della chiesa: in difetto di ciò che l'erede (il Cottolengo) potesse e dovesse esigere il rimborso dell'intera somma.
Il Servo di Dio fu pure rettore ed amministratore del santuario di Sant'Ignazio, secondo l'atto già inserito. In questa qualità, lessi nei registri del santuario (che conservo come rettore del santuario stesso) che a supplire alle spese occorrenti per il santuario (cioè per la chiesa, il fabbricato, e la strada da Lanzo) egli impiegò del suo lire ventimila duecento sessantacinque. Per altro diede il denaro ad imprestito senza interesse all'amministrazione del santuario, con approvazione dell'autorità ecclesiastica. Il Servo di Dio nel testamento condonò detta somma, mettendo la clausola che continuasse la destinazione del santuario per gli esercizi spirituali e le solite funzioni della chiesa: in difetto di ciò che l'erede (il Cottolengo) potesse e dovesse esigere il rimborso dell'intera somma.
Parte della somma suddetta impiegò, come vidi in quei registri, nel fare la gradinata esterna in pietra lavorata, in sostituzione di rozzi gradini; nell'aumentare il fabbricato della casa, a levante e ponente, delle due parti laterali alla chiesa, colle celle sottostanti; nell'ampliare e sollevare di un piano la casa così detta del cappellano; nel fare le gradinate interne della casa coi cancelli in ferro. Nella chiesa poi, che decorò con finto marmo e riquadrature, eresse l'altare della Madonna sotto il titolo di Refugium Peccatorum e provvide un bell'apparato di candelieri e piramidi per le feste. Sovratutto poi ne spese nella compra di terreni e lavori occorrenti pel compimento della strada.
Predicò sovente egli stesso gli esercizi spirituali, come già ho detto sopra, e procurò sempre che vi fossero altri dotti e pii predicatori, come il Canonico Giordano, il prof. Carlo Ferri e religiosi della Compagnia di Gesù, della Congregazione della Missione, e degli Oblati di Maria Vergine.
Presiedeva egli stesso, per quanto poteva, a tutte le mute degli esercizi e come lessi in varie relazioni, che ho già presentate, quasi tutti, sacerdoti e secolari, si confessavano da lui.
La cura speciale che aveva poi pel buon andamento degli esercizi appare dalla relazione, che presento, del defunto barone Feliciano Ricci des Ferres, che vi intervenne molte volte, secondo che egli stesso mi disse. La stessa cosa appare da una noterella scritta di mano del Servo di Dio sovra l'orario che si teneva appeso alla porta della chiesa, nella quale raccomanda in modo speciale di dire adagio, e colle pause all'asterisco, il divino ufficio; noterelle che lessi io stesso nel cartello-orario, che conservo.
CONSIGLIERE DI VESCOVI E SACERDOTI
Il Canonico Elia Giovanni Antonio, curato attuale della Metropolitana di Torino, e Don Savio, già sopra nominato, mi scrissero che Monsignor Fransoni si consigliava da Don Cafasso; e Don Savio aggiunge che, cacciato Monsignor Fransoni in esilio, disse al suo vicario generale Mons. Fissore queste parole: s'intende che farete molto capitale di Don Cafasso. Don Savio dice di aver ciò saputo da un insigne ecclesiastico, di cui non mi disse il nome. Il Canonico Elia non mi scrisse come seppe ciò che mi mise in carta. Don Buzzani, vivente, prete della Piccola Casa della Divina Provvidenza, mi disse di aver udito da Mons. Gianotti, vescovo di Saluzzo, che vari vescovi, e lui in particolare, avevano perduto alla morte di Don Cafasso un caro consigliere, a cui ricorrendo sapevano sempre di ricevere risposte tali da restarne soddisfatti.
Presento qui la attestazione scrittami dal Canonico Roetti, già nominato, che contiene molte cose riguardo il ministero di consigliere esercitato dal Servo di Dio.
Il Canonico Bosso, già menzionato, scrissemi che andavano da Don Cafasso per consigli i vicari Ravina e Fissore, il clero dell'archidiocesi e diocesi limitrofe, perché il Servo di Dio aveva il dono del consiglio in modo superlativo. Non mi aggiunge come abbia saputo queste cose.
Il Teol. Roberto Murialdo, detto volgarmente il Santo, defunto, mi disse che al Servo di Dio ricorrevano volentieri i preti, certi di trovare consiglio e conforto, e non mi disse come abbia ciò saputo. Il Canonico Giuseppe Cerutti della cattedrale di Asti, defunto, mi scrisse queste cose: fui professore di teologia, fui parroco, fui canonico penitenziere della cattedrale, e in tutti questi cinquanta e più anni del mio ministero sono più volte ricorso a Don Cafasso per consiglio, e sempre ne fui edificato e diretto secondo lo spirito del Signore. Una volta che non ho per mia disgrazia seguito pienamente i suoi suggerimenti ebbi a pentirmene e piangere.
Il Canonico Maderni, arciprete attuale di Domodossola, mi scrisse le seguenti parole: tanti consigli avuti da Don Cafasso mi furono, e ne ringrazio Dio, guida e conforto nei miei dubbi e nelle mie fatiche.
Don Carlo Bernardi, prevosto attuale di Lombardore, mi scrisse le seguenti cose: Don Cafasso era l'uomo dei consulti, cui ricorrevano da ogni parte. Nel dar consigli e nel rischiarare i dubbi egli dopo aver avuto la santa pazienza di lasciar dire e sentire tutto, dava, in poche parole sì ma chiare, il suo parere e scioglieva le difficoltà con tale precisione e brevità, che non solo se ne restava pienamente convinti e tranquillizzati, ma si trovava nella sua parola una guida sicura che toglieva ogni pena. Non mi disse come seppe queste cose per riguardo ad altri, ma mi scrisse che ne fece egli stesso per suo conto esperienza più volte.
Il Canonico Giovanni Battista Rolando, attuale prevosto e vicario foraneo di Revello (Saluzzo), mi disse come egli indeciso sulla sua vocazione al sacerdozio venne a Torino per consigliarsi da Don Cafasso, che era riputato il consigliere di tutto il Piemonte. Il Servo di Dio dopo poche domande lo accertò della sua vocazione, sicché ritornato tranquillo a Saluzzo e riferita la cosa a Mons. Gianotti, questi si dimostrò molto contento della sua an data a Don Cafasso, e della decisione datagli da lui.
La marchesa Giulia di Barolo Suor Elisabetta dell'Istituto di Sant'Anna, vivente e molto avanzata in età, mi scrisse che udì la marchesa di Barolo a dire, che chi aveva bisogno di consiglio andasse da Don Cafasso.
Il Canonico Giovanni Lanza, già menzionato, nella citata vita della marchesa di Barolo, a p. 149 scrive che Don Cafasso fu le tante volte consigliere e distributore delle elemosine della marchesa.
Il medesimo Canonico Lanza nella stessa Vita scrive che una mattina la marchesa ricevette una lettera che le notificava di entrare in possesso di una cospicua somma da volgere a scopo di beneficenza, ed interrogò Don Ponte suo cappellano, defunto, che ne dovesse fare. Don Ponte rispose che ci avrebbe pensato e si sarebbe consigliato. Andò infatti da Don Cafasso (suo consigliere, come egli stesso mi disse di averlo avuto) e consigliatosi col medesimo, la stessa sera propose alla marchesa l'erezione di una casa ove ricettare una schiera di preti secolari, i quali, stando agli ordini dell'Arcivescovo, si recassero a dar missioni, a supplire parroci e viceparroci ammalati. La marchesa esclamò a questa proposta: eccellente idea! Dispose subito di trecentomila lire a questo fine e dié l'incarico a Don Ponte di cercare il sito adatto all'esecuzione. Se non che insorsero varie difficoltà; tuttavia la marchesa non cessava dal sollecitare, persuasa del gran vantaggio spirituale che ne sarebbe derivato. Questo pare sia succeduto poco prima della morte del Servo di Dio. Nel 1862 si eresse a tal fine la chiesa di Santa Giulia con annesso fabbricato per uso di un convitto di sei sacerdoti, per mantenimento dei quali assegnò la rendita annua di lire dodicimila, come lessi nel testamento della marchesa.
La marchesa Maria Fassati, vivente, già accennata, mi scrisse che i pareri di Don Cafasso erano miti, ma decisivi ed autorevoli. Egli trovava i modi più concilianti senza concedere mai un attimo oltre il dovere.
La medesima mi disse il fatto seguente. Nel 1860, epoca dell'invasione delle Romagne, un nobile giovane che non mi nominò, si trovava impiegato alla corte del Re Vittorio Emanuele, dal quale era particolarmente amato. La sua posizione era al medesimo giovane cara e vantaggiosissima, perché ristretto di fortuna. Il suo dovere l'obbligava a seguire il Re nel viaggio che faceva a Bologna, ma la sua coscienza pareva non glielo permettesse. Partecipò la sua pena e perplessità ad una persona amica (che non mi disse chi fosse) la quale lo esortò a chieder consiglio a Don Cafasso. Egli già aveva chiesto consiglio ad altri, cioè al Signor Durando, Superiore dei Preti della Missione, defunto, senza aver trovato una vera decisione, ed il suo cuore retto e leale non poteva riposare su di una mezza misura. Egli andò da Don Cafasso, il quale, sentitolo, gli rivolse queste parole: è disposto a fare questo sacrificio per amore di Dio? e risposto di sì, malgrado che ne sentisse tutta la pena, Don Cafasso gli disse di dare le sue dimissioni. Ciò che egli fece e, fatta Pasqua, si ritirò in campagna. Ciò seppe la marchesa dallo stesso giovane. Don Balladore, attuale parroco di Bei-nasco, mi scrisse quanto segue: quando il Governo' sardo si impadronì delle Legazioni si voleva obbligare i parroci a cantare il Te Deum. Interrogato Don Cafasso se non ci fosse qualche lecito arzigogolo per esimersi con garbo da tale vessazione, il Servo di Dio disse: e che altro si può fare che dire un no rotondo? E rispondendoglisi che faceva caldo a rispondere così, il Servo di Dio riprese: caldo o freddo, non c'è altro da dire. Non mi aggiunse come seppe questo fatto.
Il conte Ottavio Bosco di Ruffino, di Torino, già nominato, mi scrisse le parole seguenti: mi è rimasta viva impressione della grande franchezza con cui più volte il Servo di Dio mi ha dato dei consigli, che mi furono sempre utilissimi.
Don Francesco Vaschetti, mi scrisse di aver udito da Don Bosco, quando circa il 1857 si trovava studente nell'Oratorio Salesiano, quanto segue. Personaggi del Governo — ci raccontò Don Bosco una sera a noi giovani radunati attorno a lui dopo la cena — mi esortano a costituire ente morale riconosciuto dal Governo quest'Oratorio, promettendomi danari e protezione. Vi esorto a pregare e a far la santa Comunione per conoscere la volontà di Dio in proposito; intanto andrò dal mio confessore Don Cafasso per averne consiglio. Il terzo giorno ci disse: Don Cafasso, dopo aver sentito che abbiamo pregato, mi disse: no, Don Bosco, non deve inceppare le mire della Provvidenza di Dio, ma deve conservarsi le mani libere per fare tutto quel bene, che il Signore si aspetta dall'Oratorio. Convinto esser questa un'ispirazione di Dio, un consiglio da santo, ci continuò a dire Don Bosco, sono tutto consolato, poiché se non avrò tanto l'appoggio del Governo, avrò tanto più l'appoggio della Divina Provvidenza.
XII - CONSIGLIERE
Il giornale L'Armonia del 26 giugno 1860, stampato a Torino, di cui posseggo una copia manoscritta rispondente al giorno suddetto, e che presenterò, scrive: tanto nella Capitale, quanto fuori il Don Cafasso era il « vir consiliorum », come sta scritto di Sant'Antonino. Si sa che, sia nel clero e sia nel laicato, chiunque avesse bisogno di un consiglio, di una direzione per regolare le partite della propria coscienza, ovvero per non inciampare nel maneggio dei più spinosi affari, ricorreva come a sicura fonte a Don Cafasso.
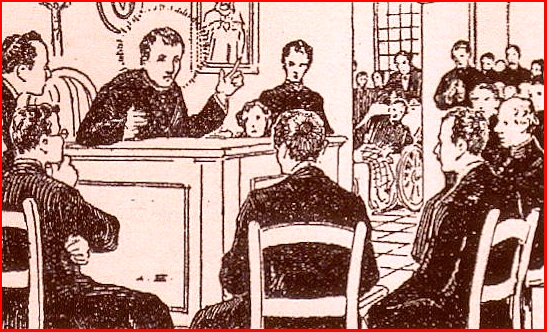
Il Campanile, altro giornale cattolico di Torino, del 25 giugno 1860, che pure posseggo, scrive:cominciando dai Vescovi e passando per tutti gli ordini, fino a quelli che il mondo considera come minimi, tutti trovano in lui (Don Cafasso) quella parola, che per essere scevra da ogni impeto umano, rivestiva la divina impronta della verità, che si attagliava a tutte le miserie sociali.
Presento ancora, in proposito dell'ufficio di consigliere di Don Cafasso, la relazione che l'attuale madre Superiora Ignazia Losa di Ternengo, del monastero della Visitazione di Torino, scrisse ricavandola in gran parte dalle circolari per la morte di alcune religiose e, in parte, da dichiarazioni orali, che essa Superiora ebbe da suore, al presente quasi tutte viventi, cioè: Suor Maria Celestina Turletti, Suor Maria Cristina Gaia, Suor Maria Gaetana Borbonese, Suor Bianca Margherita Adami.
Delle lettere del Servo di Dio, di cui posseggo una settantina, la massima parte furono da lui scritte per dare consigli.
FEDELE SERVO DEL SIGNORE
Che abbia adempiuto in tutto il tempo di sua vita esattamente i Comandamenti di Dio e della Chiesa e le obbligazioni del proprio stato, non che quelle dei suoi uffici, resta provato da quanto ho già finora deposto.
Inoltre Don Bosco, già nominato, nella biografia del Servo di Dio già citata, a pag. 67 scrive le seguenti cose: Ogni parola, ogni pensiero, ogni opera di Don Cafasso, dalla più tenera età sino all'ultimo istante di vita, fu una costante pratica dei suoi doveri verso Dio, verso gli uomini, verso se stesso. Il medesimo Don Bosco prese per testo dell'orazione funebre, che recitò in San Francesco per il Servo di Dio, le parole della S. Scrittura: operatus est bonum et rectum et verum in universa cultura ministerii domus Dei, e su questo testo svolse tutta l'orazione sua.
Don Bosio, prevosto di Levone, defunto, nella già presentata relazione scritta al Can. Colombero, che me la rimise, dice: impegno continuo e studio di Don Cafasso fu di far cessare il peccato, amare Dio ed il prossimo e così salvare le anime.
Don Ribotta Nicola, già nominato, mi scrisse: Don Cafasso faceva tutto il bene possibile all'unico fine di condurre gli uomini a Dio.
Don Carena Biagio, vivente, mi scrisse: non ho mai scorto in Don Cafasso il minimo difetto, anzi l'ho sempre ammirato in tutte le sue parole, in tutte le sue azioni veramente esemplare e santo.
Don Matta Pietro, nipote del servo di Dio, defunto, mi scrisse: non ebbi mai a notare in lui alcun neo.
Don Rolando Domenico, già nominato, mi scrisse: l'ho studiato sotto ogni aspetto con tutta l'attenzione, ma non potei rilevare in lui imperfezione di sorta.
Il Teologo Gallo Giorgio, vivente, che dimorò in Convitto nel 1844-'45 e nel 1845-'46, mi scrisse:in tutto questo tempo io affermo con tutta sincerità che sono stato veramente edificato dalla condotta veramente esemplarissima di Don Giuseppe Cafasso, e che non vidi mai un'azione qualunque, né udii da lui una parola che non convenisse ad un santo sacerdote e fui testimone oculare delle più belle virtù.
Don Bosco, già nominato, scrisse al Can. Colombero: mentre generalmente la convivenza fa diminuire la stima, che prima si aveva di una persona, pei difetti che colla convivenza vengono a scoprirsi, invece chi stimava per fama Don Cafasso prima di convivere con lui, dopo vari anni di sua convivenza gli accresceva la stima.
Don Bosco nella citata biografia (pag. 72) scrive: Ho interrogato parenti, amici, compagni di scuola ed altri personaggi che ebbero lunga conoscenza di lui, e tutti concordano in asserire, che nei 49 anni di vita, loro non fu mai dato di notare un gesto, uno sguardo, una parola od una sola facezia meno dicevole ad un giovane virtuoso, ad un chierico esemplare, ad un santo sacerdote.
DUE OBIEZIONI MOSSE AL SERVO DI DIO
In vita mia due sole cose udii addossare al Servo di Dio; cioè la che egli abbia aiutato il suo fratello ad arricchirsi; 2d che abbia danneggiato il Convitto col non lasciarlo erede.
1° La prima cosa udii da certo Marchisio Giuseppe di Castelnuovo d'Asti, defunto. Chiestogli io il perché del suo asserto, mi rispose che egli credeva il Servo di Dio avesse aiutato suo fratello Pietro, defunto, a fabbricarsi la nuova casa che si fece in Castelnuovo, e ciò arguiva dal fatto, che durante i lavori di quella casa vedeva spesso a presenziare quei lavori il beneficiato Don Ropolo, defunto, che tutti sapevano essere in Castelnuovo il dispensiere delle limosine del Servo di Dio. Interrogai allora Don Ropolo stesso, il quale mi rispose che non ebbe mai un soldo da Don Cafasso per quella fabbrica, né per fratello Pietro. E vero, mi soggiunse, che io visitavo quei lavori, ma questo facevo solo per passatempo e perché era amico della famiglia, e conchiuse dicendomi che per quanto ne sapeva lui, don Cafasso non c'entrò menomamente in tali lavori.
Che non volesse arricchire il fratello, appare dal fatto che, sebbene questi si offrisse ad aiutarlo come espertissimo nell'amministrazione delle varie cascine, egli non lo volle mai lasciare entrare, come mi disse il Sig. Bargetto; non ricordo come abbia ciò saputo, ma parmi dicesse di averlo sentito dallo stesso Pietro. Tutto ciò che fece a favore del fratello fu di lasciargli godere, finché visse, i suoi pochi beni di famiglia, dei quali poi lo lasciò erede in morte, coll'obbligo però di pagare lire cinquecento a ciascuna delle sue sorelle, come io lessi nel suo testamento. L'entità di questi beni, a norma dell'inventario, che feci consultare, ascendeva a lire quattromila. È vero che Cafasso Pietro accumulò un discreto patrimonio, così da diventare da semplice particolaretto uno dei migliori possidenti campagnoli del paese. Ma ciò provenne, come udii sempre a dire nella mia famiglia e nel paese, dall'aver egli sposato una figlia unica e ricca, dalla sua rara capacità nell'amministrare le sue sostanze, dalle annate assai favorevoli ai vignaiuoli che vi furono allora, per cui molti nel mio paese, produttori e negozianti di vino, come lui, arricchirono. La stessa mia madre, rimasta vedova con cinque figliuoli in tenera età, poté col nostro mediocre patrimonio avviare agli studi tre di noi, e tuttavia accrebbe la nostra sostanza di circa 12.000 lire; e ciò senza che Don Cafasso, che pure le voleva tanto bene, l'abbia mai aiutata di denaro, come essa stessa mi disse. Mons. Rossi, attuale vescovo di Pinerolo, già Prevosto di Castelnuovo, scrisse al Can. Colombero la lettera che io tengo, nella quale leggo che dal fatto della frequenza di Don Ropolo in casa Cafasso. durante la fabbricazione della sua nuova casa, taluno credette che vi andasse per pagare quei lavori coi denari di Don Cafasso, ma che egli non crede che il fratello si sia fatto ricco coi denari di Don Cafasso.
Don Matta Pietro, nipote del Servo di Dio, già direttore degli studi all'Istituto delle Rosine in Torino, come mi disse più volte mia madre, non fu aiutato negli studi dallo zio Don Cafasso, per cui la madre del Matta dovette fare gravi sacrifici, fino a vendere il suo oro da sposa. Lo stesso Don Matta mi scrisse che, fatto sacerdote, esimendosi di entrare in Convitto come desiderava lo zio, ma volendo continuare la sua dimora nel Collegio dei Barnabiti a Moncalieri, col pretesto delle sue strette condizioni economiche, lo zio gli rispose che cuori amorevoli e riguardi alle povere finanze ne avrebbe pure trovati in Convitto.
2° La seconda cosa lessi nella Storia della Chiesa in Piemonte (vol. IV, p. 6) stampata in Torino per opera del Teologo Chiuso, ed è che Don Cafasso abbia concorso a far decadere il Convitto dalla sua floridezza, col non lasciarlo erede.
Premetto che Don Cafasso fece il testamento quattro anni prima di morire. cioè il 10 ottobre 1856, e lo presentò al Magistrato d'Appello il 20 dello stesso mese, come vidi nella copia che posseggo; né più vi fece mutazione. Lo fece adunque con piena serietà di giudizio. In esso non toccò menomamente i beni del Convitto, perché questo, come ente morale, li possedeva in proprio. Condona però al medesimo le somme spese del suo per pareggiare i conti annuali, cioè, come lessi nei registri del Convitto, la somma totale di lire ventimilacinquecentosessantasette. Dispone poi dei suoi pochi beni di famiglia a favore del fratello e delle sorelle. E, fatti vari legati, tutto il resto lascia al Canonico Anglesio, Padre della Piccola Casa (Cottolengo), un patrimonio ascendente alla somma di mezzo milione, se è a credersi alla voce comune. Perché non abbia lasciato questi beni al Convitto, non mi consta che l'abbia detto. Noto solo che con ciò non fece alcun torto al Convitto, trattandosi di beni che a questo non appartenevano.
Gli erano pervenuti dall'eredità lasciata al Teol. Guala dalla Contessa Rombelli, e, come in vita, ne spese sempre i proventi in opere di carità, così lasciò in morte a quella meravigliosa Opera di carità che è il Cottolengo. In ciò avrebbe secondato l'intenzione del Teol. Guala perché, come mi disse Bargetto sopracitato, avendo Don Begliatti una volta avanzata qualche osservazione sulla tanta carità che faceva Don Cafasso fuori del Convitto, il Servo di Dio gli rispose senz'altro che in ciò operava conforme all'intenzione del Teol. Guala.
Aggiungo che il Convitto non ne aveva assoluta necessità, potendo andare innanzi colle sue rendite, le pensioni dei Convittori, e l'indennità che la chiesa di S. Francesco doveva pagargli pel servizio che i Superiori e i Convittori le prestavano coll'officiarla. Tuttavia Mons. Bertagna mi disse che Don Cafasso, morendo, raccomandò a voce al suo erede il Convitto pel caso che ne avesse bisogno, e che in principio, realmente, ne dava. Non mi disse poi Mons. Bertagna da chi seppe quella raccomandazione.
In tutto ciò non si vede come abbia causato la decadenza del Convitto. Forse il timore di sollecitare le voglie del fisco, che allora andava incamerando i beni dei religiosi, fu motivo per cui non lasciò al Convitto, come ente morale. Forse lo spinse a ciò fare il riflesso che i nemici della morale di S. Alfonso, i quali tenevano tuttora importanti posti nell'Archidiocesi, avrebbero più volentieri tentato di porsi a capo di un'Opera, che fosse molto ricca, e così deviavasi l'andamento.
Questo timore il Servo di Dio l'aveva certamente, perché nel testamento pose la clausola mercé cui se il Convitto avesse cambiato spirito, il suo erede avrebbe avuto diritto ed obbligo di esigere tutti i debiti del Convitto verso Don Cafasso, debiti che aveva condonati.
Presento qui la copia del testamento del Servo di Dio. Aggiungo ancora che Cafasso Giuseppe, figlio di Pietro e quindi nipote del Servo di Dio, vivente, mi scrisse che essendo andato a trovare lo zio nella sua ultima malattia, questi gli disse: la roba che è a Castelnuovo è per i parenti, al resto non ci pensate, è roba dei poveri e deve andare ai poveri.
XIII - «MI RESTITUISCONO I NÓCCIOLI»
 Il Servo di Dio fu a parte della persecuzione mossa contro il convitto dai liberali, e dai seguaci della morale rigoristica. Egli colla sua mitezza e moderazione - come scrive Don Bosco nella citata biografia, ed il Prof. Carlo Ferrero nel periodo l'Apologista (1860, N° 37) - riuscì ad introdurre il vero spirito della Morale Cattolica. Non ho particolari in proposito.
Il Servo di Dio fu a parte della persecuzione mossa contro il convitto dai liberali, e dai seguaci della morale rigoristica. Egli colla sua mitezza e moderazione - come scrive Don Bosco nella citata biografia, ed il Prof. Carlo Ferrero nel periodo l'Apologista (1860, N° 37) - riuscì ad introdurre il vero spirito della Morale Cattolica. Non ho particolari in proposito.
Ebbe a sopportare molestie ed insulti nel ministero esercitato nelle carceri, 1° quando - come mi disse Sebastiano Berti, vivente, domestico del Convitto e presente all'atto - avendo il Servo di Dio regalato ai carcerati un canestro di ciliege, alcuni carcerati si divertirono a gettargli in faccia i nòccioli, ed egli tranquillo e sorridente diceva al domestico Berti, che ne era indignato: Vedi mi restituicono i nòccioli; lasciali un pò, non hanno altri divertimenti, poveretti! Mi pare dal modo con cui raccontò la cosa il Berti, che i carcerati non facevano ciò per isfregio, ma piutosto per la loro grossolanità e per la famigliarità con cui il Servo di Dio li trattava.
2° Quando fu preso pel collo da un carcerato, come già ho deposto più sopra.
3° Quando fu chiuso in carcere, come pure già dissi.
4° Quando - come mi scrisse il Canonico Gaude, dicendomi d'averlo udito dallo stesso Servo di Dio - trovandosi nel Confortatorio, un condannato che, legato al muro, furibondo malediceva tutti e ingiuriava anche il Servo di Dio, egli, inginocchiato in un angolo pregava e rispondeva alle ingiurie, dicendogli: Non vi faccio male; lasciate che preghi per voi il Signore. Il condannato continuando ad arrabbiarsi, il Servo di Dio raddoppiava il fervore della preghiera, poi rivoltosi al medesimo, gli parlò così: Ditemi un po', l'avete ancora vostra madre? Avutane risposta affermativa, Don Cafasso soggiunse: Che direbbe vostra madre, se vi vedesse a fare così? Qual disgusto per lei, già disgraziata di avere un figlio che muore sul patibolo senza aver ricevuto i sacramenti! A questi ed altri riflessi si acquietò si diede per vinto, ricevette i sacramenti e fece una buona morte. Il Canonico Barbiè, nella relazione che già ho presentato, narra che nel 1841 un tale fingendosi convertito e, avendo concertata col Servo di Dio l'ora in cui doveva venire a confessarlo, lo attese mentre passava sotto la finestra e gli gettò addosso un liquido ributtante. Ma egli, senza perdere la calma, si presentò a lui egualmente e lo confessò.
Suor Paola, Vicaria dell'Istituto delle Maddalene di Torino, molto avanzata di età ed ora inferma, mi scrisse il 28 dicembre 1894 quanto segue: Sono passati 46 anni dal giorno in cui assistei a un atto brutale fatto al Reverendo Don Cafasso e lo ricordo tuttora con dolorosa commozione. Mi recavo ad accompagnare alcuni bambini all'asilo, quando, giunta in via dell'Ospedale, vidi un gruppo di giovani che, dall'aspetto e dal vestito, mi parevano studenti, i quali stavano affollati attorno a un sacerdote (era Don Cafasso) e lo caricavano d'ingiurie e vituperi. Uno di essi gli diede un ceffone gettandogli in aria il cappello, un altro lo gettò a terra presso il canaletto d'acqua che scorreva in mezzo alla strada, ed altri con pugni e urtoni gli facevano mettere la faccia nell'acqua. Il restante di quella ciurmaglia sghignazzava e applaudiva quell'azione nefanda verso un ministro di Dio. Il povero sacerdote tentava invano di rialzarsi da terra dove l'avevano gettato, perché appena lo vedevano sollevato sulle ginocchia lo spingevano nuovamente nell'acqua. Era una scena da strappare le lacrime, e chi sa fino a quando sarebbe durata se non arrivava un signore, il quale, con gesti autorevoli e con parole di giusto sdegno, rimproverò quei giovinastri di quell'atto nefando verso una persona così rispettabile, e che aveva fatto loro nessun male, e li obbligò alla fuga. La povera vittima, rimasta sola, si alzò con calma, andò a prendersi il cappello, che gli avevano gettato dalla parte opposta della strada, e come meglio potè riprese il suo cammino senza dare il minimo segno di sdegno o di risentimento.
Patì pure nella perquisizione fatta al Servo di Dio nella sua camera del Convitto sotto il ministro Farini, come mi disse il Padre Bosso della Piccola Casa, che mi soggiunse essere stata causa occasionale della sua morte. Di questa perquisizione scrissero i giornali che presento, cioè l'Armonia (1860 - 9 e 26 giugno) in manoscritto, ed il Campanile (1860 - 25 giugno) e la Civiltà Cattolica (quaderno 1° luglio 1860). Questa prova dal Servo di Dio fu sostenuta con fortezza cristiana, come consta:
1° Da ciò che mi disse la Damigella Lorenzina Mazé de La Roche, vivente, cioè d'aver udito dalla nonna Margherita Volpato vedova Gastaldi a narrare che intimata la perquisizione a Don Cafasso mentre stava confessando in chiesa, egli diede le chiavi delle camere e, senza scomporsi, continuò a confessare come se nient'altro l'interessasse. Non mi disse come la Volpato abbia ciò saputo.
2° Da Don Giacomelli, vivente, il quale mi disse aver udito il Servo di Dio a rispondere sorridendo a una signora che lo compativa per la patita persecuzione: Un prete da forca, come son'io, non se la prende per queste cose.
Posseggo un libro delle Rubriche Missalis Romani, nel quale il Servo di Dio scrisse il Memento dei vivi e dei morti per proprio uso, nel quale, tra le altre preghiere, c'è pure quella per i suoi nemici.
LA FEDE DI DON CAFASSO – PREGHIERA
Il Canonico Bosso, già nominato, mi scrisse che la fede del Servo di Dio fu ferma, profonda, universale, e le sue opere erano tutte animate dalla fede. Di ciò in parte fu testimone ed in parte seppe da altri, di cui non mi disse il nome.
Don Claudio Milano, vivente, già nominato, mi scrisse che la vita del Servo di Dio fu una vita di fede la più viva, tanto nei detti quanto nei fatti.
Il Servo di Dio ringraziava il Signore ogni giorno di averlo creato e fatto cristiano, perché, come ho già detto, fin da fanciullo recitava le preghiere, e, fatto sacerdote ed entrato in Convitto, lo ringraziava inoltre di essere stato chiamato al Sacerdozio, perché sino alla morte recitava abitualmente le orazioni dei Convittori, le quali orazioni contengono questi sentimenti. Che andasse a recitare le orazioni in comune, lo so dal Canonico Barbiè, defunto, da Don Siccardi, vivente, da Don Martino, già nominato, defunto, convittore nel tempo del Servo di Dio. Nel giorno del ritiro mensile che, per attestazione di Don Bosco, stampata nella citata biografia, soleva fare una volta al mese, egli recitava una preghiera da sé composta, che posseggo in originale, nella quale si legge: Rendo grazie infinite a quel buon Dio, che per tratto di sua pura e speciale misericordia, ha voluto nel mio nascere chiamarmi alla fede e portarmi qual figlio, tutto che immeritevole, nelle braccia della Santa Chiesa Cattolica. Rinnovo in oggi quelle promesse e proteste che un giorno al sacro fonte si fecero per me. Piango e detesto quanto nella mia vita non vi fu conforme. Condanno e rigetto tutto ciò che nei miei giorni fosse stato mancante d'ubbidienza e rispetto alla Santa Romana Chiesa. Oggi e per sempre protesto di voler vivere e morire nella comunione più stretta di questa madre... e quando il Signore chiamerà il sacrificio della mia vita, intendo d'unirlo a quello che hanno fatto tanti confessori della fede, ed esalare l'ultimo mio spirito in omaggio e sostegno della nostra fede santissima. Il suo amore alla S. Chiesa ed alle Autorità Ecclesiastiche appare da questo che, nel Memento che Don Cafasso si scrisse per suo uso e che io conservo, mette per prima cosa in quello dei vivi: Commendo Tibi Sanctam Romanam Ecclesiam omnesque necessitates
Praelatorum et sacerdotum, ed in quello dei morti: memento animarum omnium Praelatorum et Sacerdotum. Monsignor Gastaldi, Arcivescovo di Torino, defunto, mi disse (non però come ciò seppe) nell'agosto del 1880, che Don Cafasso aveva fatto tanto bene, anzi prodigi, perché era uomo di orazione.
Mons. Galletti, Vescovo di Alba, defunto, nel 1867 in tempo di esercizi spirituali al suo Clero, insegnando il modo di dire il Breviario, distribuì a ciascuno dei sacerdoti un foglietto stampato colà, cui pose in titolo: Noterelle sulle intenzioni della S. M. di Don Giuseppe Cafasso per le ore canoniche, e continuò a distribuirlo per più anni, e ne teneva egli stesso una copia come segnacolo in ciascuna delle quattro parti del Breviario. Tutto ciò mi scrisse il Canonico Allaria, segretario di Mons. Galletti. Ed io ebbi da un sacerdote della diocesi d'Alba uno di questi foglietti, nel quale leggo:
Mattutino, pei presenti bisogni di Santa Chiesa.
Lodi, per la conversione di qualche peccatore.
Prima, in suffragio di qualche anima purgante.
Terza, per ottenere una grande purità d'intenzione.
Sesta, per ottenere una profonda umiltà.
Nona, per ottenere la virtù della purità.
Vespro, per fare una buona morte. Compieta, per il perdono del purgatorio.
Don Bosco, nella citata biografia, scrive che il Servo di Dio faceva ogni giorno la visita al SS. Sacramento. Il Servo di Dio, in una predica manoscritta che conservo, parlando della visita al SS. Sacramento, la chiama fra le pie pratiche della giornata del sacerdote, l'azione più grande, più santa e più esemplare pel popolo: pratica di Paradiso.
Il Canonico Barbiè, già nominato, nella relazione già presentata, parla molto bene della preparazione, della celebrazione, e del ringraziamento che faceva il Servo di Dio alla S. Messa.
Il Canonico Bosso mi disse che vide il Servo di Dio dopo la celebrazione della S. Messa, che sembrava trasformato e raggiante nel volto ed in lui si scorgeva alcunché di sovrumano e di celestiale.
Don Momo, defunto, già nominato, mi scrisse che l'angelico abituale raccoglimento di Don Cafasso nelle funzioni del sacro ministero faceva pensare che ci vedesse proprio la sacrosanta Umanità di Gesù Cristo, e si sentisse compenetrato, assorbito, fra gli splendori di lui.
Il Servo di Dio fu divoto della Passione di N. S. Gesù Cristo.
Questo consta:
1 ° dall'impegno che poneva nella funzione detta della Corda Pia, che consisteva nella pratica della Via Crucis solenne in tutti i venerdì di quaresima nella chiesa di San Francesco, come mi dissero di aver veduto Don Giacomelli ed il Sig. Bargetto.
2° Da ciò che scrisse Don Tonietto, già nominato nella presentata relazione, nella quale dice che era voce comune tra loro convittori, che per attendere alla preghiera si mettesse a letto a notte molto inoltrata, la quale passava anche intiera ai piedi del Crocifisso quando doveva accompagnare qualche disgraziato all'estremo supplizio.
3° Dalle prediche composte sulla Passione del Signore, che io conservo nel loro originale, da riuscire una completa meditazione su tutta la Passione del Signore.
4° Da una predica del Servo di Dio su San Giuseppe, di cui pure conservo il manoscritto, nella quale si leggono queste parole: Prendiamo il bel costume di baciare di tanto in tanto il Croci
fisso; raccomando ben di cuore questa pratica di fede, affinché Dio ci faccia la grazia di poterlo baciare, e non sia la prima volta, sulla fine dei nostri giorni.
5° Da Sebastiano Berti, il quale mi disse d'aver visto il Servo di Dio a digiunare ogni venerdì, e in tal giorno a prendere il caffè senza zucchero nel dopo pranzo; di che, avendo egli fatto osservazione al Servo di Dio, questi rispose: A Gesù in croce non fu dato che fiele.
